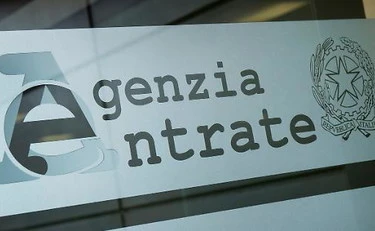L’Italia ha attraversato la tempesta degli ultimi tre anni (uscita dalla crisi pandemica, ingresso in una guerra nel cuore dell’Europa, crisi energetica e delle materie prime con picco dell’inflazione, cambio radicale di scenario politico in America, collasso del sistema del commercio mondiale) con un’ottima prova di resistenza e reazione. Il bilancio dello Stato è gestito con prudenza, lo spread è ai minimi e vicino a quello della Francia (con gli elogi del quotidiano Le Monde per il governo Meloni), l’occupazione è al record storico, i prezzi sono sotto controllo. Il governo ha agito con saggezza e continuerà a seguire questa linea perché si è aperta una nuova fase. “America First” non è uno slogan, è una politica a 360 gradi, si traduce in una serie di azioni del governo degli Stati Uniti e del suo sistema di imprese che operano nei settori chiave della contemporaneità.
Le difficoltà dell’Unione europea sono visibili, è finita l’era del “pilota automatico”, ma alla guida restano leader (e formule politiche) che sono invecchiati in un lampo. Ci raccontano cosa è successo, ma non sono in grado di dirci cosa accadrà e come pensano di affrontare la sfida. Christine Lagarde, la presidente della Bce ieri in un discorso a Ginevra ha detto che i dazi porteranno a un rallentamento della crescita in Europa. Grande scoperta, soluzioni?
Quello di Lagarde è il classico oracolo che dice «piove», ma non apre neppure l’ombrello. I dazi ci sono e resteranno e a questo si aggiunge un altro fattore - che Lagarde non ha citato - fondamentale: il dollaro debole rispetto all’euro penalizza l’export, è diventato un altro dazio aggiuntivo. Quali strumenti intende mettere in campo la Bce? Qual è la rotta della nave di Francoforte?
Mistero. Per sapere, per capire, sono più utili le minute della Federal Reserve pubblicate ieri: il consiglio della banca centrale americana è diviso sulle previsioni e sulla risposta da adottare (il taglio dei tassi), il maggior elemento di incertezza dell’economia americana per ora non è il mercato del lavoro (le imprese «non assumono e non licenziano» perché attendono un quadro più stabile), ma l’inflazione, l’impatto dei dazi. Ci sarà davvero un forte aumento dei prezzi? È un rischio, ma il trasferimento dei costi sul consumatore non è automatico e le imprese stanno già adottando diverse strategie: «La negoziazione con i fornitori o il cambio dei fornitori stessi, la modifica dei processi produttivi, la riduzione dei margini di profitto, una maggiore disciplina salariale o lo sfruttamento di misure di efficienza volte al risparmio dei costi, quali l’automazione e le nuove tecnologie», senza dimenticare che «nelle attuali condizioni la domanda limita la capacità delle imprese di trasferire i costi tariffari sui prezzi».
Questo brano delle minute della Fed è molto interessante, racconta il dinamismo dell’economia americana, la capacità di adattamento, rivela il modo in cui la Federal Reserve analizza lo scenario, discute, presenta agli americani, alle famiglie e alle imprese, le sue decisioni. Trump non perde occasione per criticare il presidente della Fed, Jerome Powell, chiede da tempo un taglio dei tassi. Venerdì Powell farà il suo intervento al simposio annuale di Jackson Hole e forse avremo uno scenario più compiuto rispetto al resoconto della riunione della Fed di fine luglio.
In un mondo nuovo, emerge ancora più nettamente la differenza tra la qualità delle azioni della Fed e il modus operandi della Bce. Sono incomparabili per qualità, chiarezza e cifra “democratica”. È un dato sul quale i leader europei dovrebbero riflettere nel momento in cui stiamo entrando in un territorio senza mappe, in una dimensione dove i governi avranno un ruolo sempre più dominante nell’economia. La Casa Bianca che si appresta all’acquisto del 10% di Intel, il gigante dei microchip, segnala l’ingresso in questa nuova era, dove il controllo di produzioni strategiche può essere la chiave della vittoria o della sconfitta. Gli europeisti si gonfiano di retorica, ma la competizione è su questo terreno: la politica monetaria (e fiscale), la capacità di produrre quello che serve per accendere e far correre il motore dell’economia.
L’ex ministro degli Esteri della Germania, Joschka Fischer, intervistato da Paolo Valentino sul Corriere della Sera, ieri ha definito il vertice di Anchorage tra Trump e Putin come «la dimostrazione dei nuovi rapporti di potenza globali nel XXI secolo, dove anche il presidente degli Stati Uniti accetta che l’impero russo è tornato». Fischer ha una visione forse apocalittica, dipinge Trump come una sciagura, ma quando afferma che «l’Europa non è una potenza. E deve iniziare da subito, in modo energico e deciso, il processo per arrivare a esserlo», ha ragione.
Non è solo una questione di Difesa, di riarmo e «porcospini d’acciaio» (Ursula von Der Leyen) è chiaro che bisogna «anche affrontare tutte le sfide legate a uno status di potenza globale: spazio, digitale, servizi di intelligence.
Il messaggio che viene da Anchorage è chiaro: siamo soli». Fischer è un veterano della sinistra europea, vede le rovine e la bancarotta culturale dei progressisti, il suo giudizio è plasmato da questa esperienza che è giunta al termine e per l’Unione si traduce, per ora, senza la prospettiva di un nuovo inizio.
«Siamo soli», dice Fisher, ma è una solitudine auto-inflitta. Il mondo sta cambiando, l’America sta rimodellando le relazioni internazionali, ha affondato il Wto (l’Organizzazione internazionale del commercio), svuotato il G7 e il G20 di cui francamente non si ricordano svolte epocali, ha preso atto del declino (prima di tutto morale) delle Nazioni Unite finite in mano a satrapi e tagliatori di teste, ha sanzionato la Corte penale internazionale (altra istituzione finita nel discredito), e ha aperto a nuovi format diplomatici di cui il vertice di Washington con i leader europei e Zelensky è un esempio. Per non essere soli, come sottolinea Fischer, l’Europa dovrebbe riformare le sue istituzioni, fare un bagno d’umiltà, staccare il pilota automatico e cambiare i conducenti - a cominciare dalla Bce- che si ostinano a seguire una rotta che va verso gli scogli.