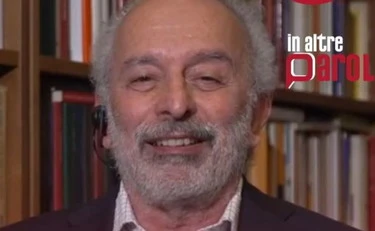Sulla Bibbia della fisica - Nature Reviews Physics, agosto 2025 - è uscito un reportage di Andrea Reichenberger che dice una cosa ovvia ma ancora rivoluzionaria: le donne nella storia della fisica quantistica ci sono e ci sono state, hanno fatto e fanno ricerca di altissimo livello, ma sono state e sono sistematicamente rese invisibili o ridicolizzate. Tema attualissimo, visto che nel mio caso - in piccolo, certo - il dibattito su un vestito estivo ha attirato più attenzione di un buco nero che parcheggia davanti a casa, e ha superato qualsiasi hit estiva nel numero di commenti. L’articolo di Reichenberger parte da un dato semplice: nei libri di storia della fisica del Novecento, le donne compaiono poco e male. Ma non perché non ci fossero. E tira fuori un riferimento nuovo: tra il 1920 e il 1924, per esempio, la rivista Physikalische Blätter pubblicò oltre 500 articoli firmati da fisiche.
La Zeitschrift fur Physik pure, con nomi come Lucy Mensing, che applicò la meccanica delle matrici allo spettro di rotazione delle molecole, o Johanna van Leeuwen, coautrice del teorema Bohr-Van Leeuwen. Donne che lavoravano fianco a fianco con i colleghi maschi, producevano scienza vera e spesso avevano vite avventurose... ma nei racconti ufficiali sono scomparse. Hertha Sponer: dottorato a Göttingen con Peter Debye, assistente di James Franck, inventrice con Raymond Thayer Birge di un metodo per calcolare l’energia di dissociazione delle molecole. Dopo un periodo in California, torna in Germania e diventa la prima donna a ottenere l’abilitazione in fisica... poi il nazismo la caccia. Si rifugia in Norvegia, poi negli Stati Uniti, dove ottiene una cattedra alla Duke University. E lì non si chiude nel laboratorio: costruisce una rete di sostegno per colleghi e colleghe rifugiati, tra cui Gertrud e Lothar Nordheim (poi nel Manhattan Project), Hedwig Kohn- pioniera della spettroscopia UV - e Hildegard Stücklen, che collabora con scienziate americane come Emma Perry Carr e Lucy Weston Pickett. Altro che “donne isolate”: era un network internazionale di ricerca, quando ancora non c’era nemmeno il fax. E poi c’è un’altra questione. Quando una donna fa fisica, il merito va sempre a un uomo. Ecco il “Matilda Effect”, battezzato negli anni ’90 dalla storica Margaret W. Rossiter in onore di Matilda Joslyn Gage, che nell’Ottocento denunciava la cancellazione delle scienziate e la loro esclusione. Il nome è un gioco, e richiama il “Matthew Effect” di Robert K. Merton - quello per cui: più sei famoso, più ti attribuiscono meriti. Beffa delle beffe: Merton lo ha elaborato partendo dalla tesi della moglie Harriet Zuckerman, che resta meno citata di lui. La Reichenberger fa notare che molti autori di libri di fisica copiano da altri libri senza mai mettere piede in un archivio. Così il racconto resta sempre uguale: una sfilata di geni maschi in ordine cronologico. E quando provi a inserire le donne in un racconto di fisica dura, come la bomba atomica o il nucleare, scatta la solita accusa: “quote rosa”, “revisionismo”, “vogliono sostituire un eroe con un’eroina”. Ma il punto non è sostituire statue: è raccontare la storia per intero. Dire che essere donna e fisica nucleare vuol dire avere discriminazioni multiple, senza nessun riconoscimento. Quando mi sono trovata nella saga “scollatura e pregiudizio”, il messaggio che volevo passare era esattamente quello dell’articolo di Reichenberger: le donne nella scienza ci sono e vanno raccontate per quello che fanno, non per come appaiono. Ma, come spesso accade, alle donne si nega la parola sulla loro competenza e la si concede agli altri per commentarne l’aspetto.
È il Matilda Effect che incontra il sessismo 2.0: invisibilità per i contenuti, iper-visibilità per ogni centimetro di pelle. E quindi? La storia della fisica non è una linea retta di uomini geniali che si passano il testimone, ma una rete complessa di idee, intuizioni, errori, correzioni e collaborazioni. Raccontarla tutta non è un favore alle donne: è un favore alla verità. E a chi dice “non cambia la fisica”, ricordo che la fisica è fatta di esperimenti e dati, ma anche di persone - alcune delle quali hanno dovuto lottare il doppio per essere ascoltate. E ricordo che Enrico Fermi scelse Leona Woods per affiancarlo al Progetto Manhattan e, quando lei rimase incinta, lui - piuttosto che privarsi di una collaboratrice che non voleva lasciare il lavoro fino all’ultimo - si mise a leggere un manuale su come farla partorire. (O, esempio attuale: cercate su Google chi ha parlato per primo di “teoria relazionale della fisica quantistica”, non troverete che la fisica Grete Hermann ha elaborato la teoria cento anni fa, ma il nome di un fisico moderno. )
Come combattere il fenomeno? Servono storie, serve l’arte, serve ricerca d’archivio, dati, analisi critica e una narrazione che integri davvero le fisiche nella storia della fisica, partendo da chi fa il racconto. Strumenti moderni come le digital humanities possono aiutare, ma bisogna fare attenzione a non riprodurre i pregiudizi già presenti. Serve un cambiamento culturale profondo e, soprattutto, istituzionale. E se comunque, a raccontare queste storie è sempre un uomo, non cambia molto: si rischia di ripetere lo stesso errore. Perché anche il racconto della scienza più dura, fino ad oggi, è stato quasi sempre visto con un volto maschile... e quando tocca a una donna, c’è sempre qualcuno pronto a chiederle «chi ti veste?» invece di «che teoria stai spiegando?». E non è solo una questione simbolica: vedere sempre e solo un volto maschile che racconta la scienza modella il nostro cervello. La neuroscienza lo chiama pattern recognition: il cervello si abitua a collegare “scienza” con “uomo” e tutto il resto diventa un’eccezione da giustificare. E infatti, quando si parla di fisica, bomba atomica o Seconda guerra mondiale, sono i machi a parlarne. L’apoteosi di questo meccanismo è il film Oppenheimer: Nolan, uomo che racconta, ci mostra la moglie di Oppenheimer come una figura che piange, cura i figli e si alcolizza, senza dire che era una scienziata del Progetto Manhattan. E, soprattutto, senza ricordare nemmeno una delle oltre 1.600 scienziate che hanno lavorato alla bomba, in 3 ore di film.