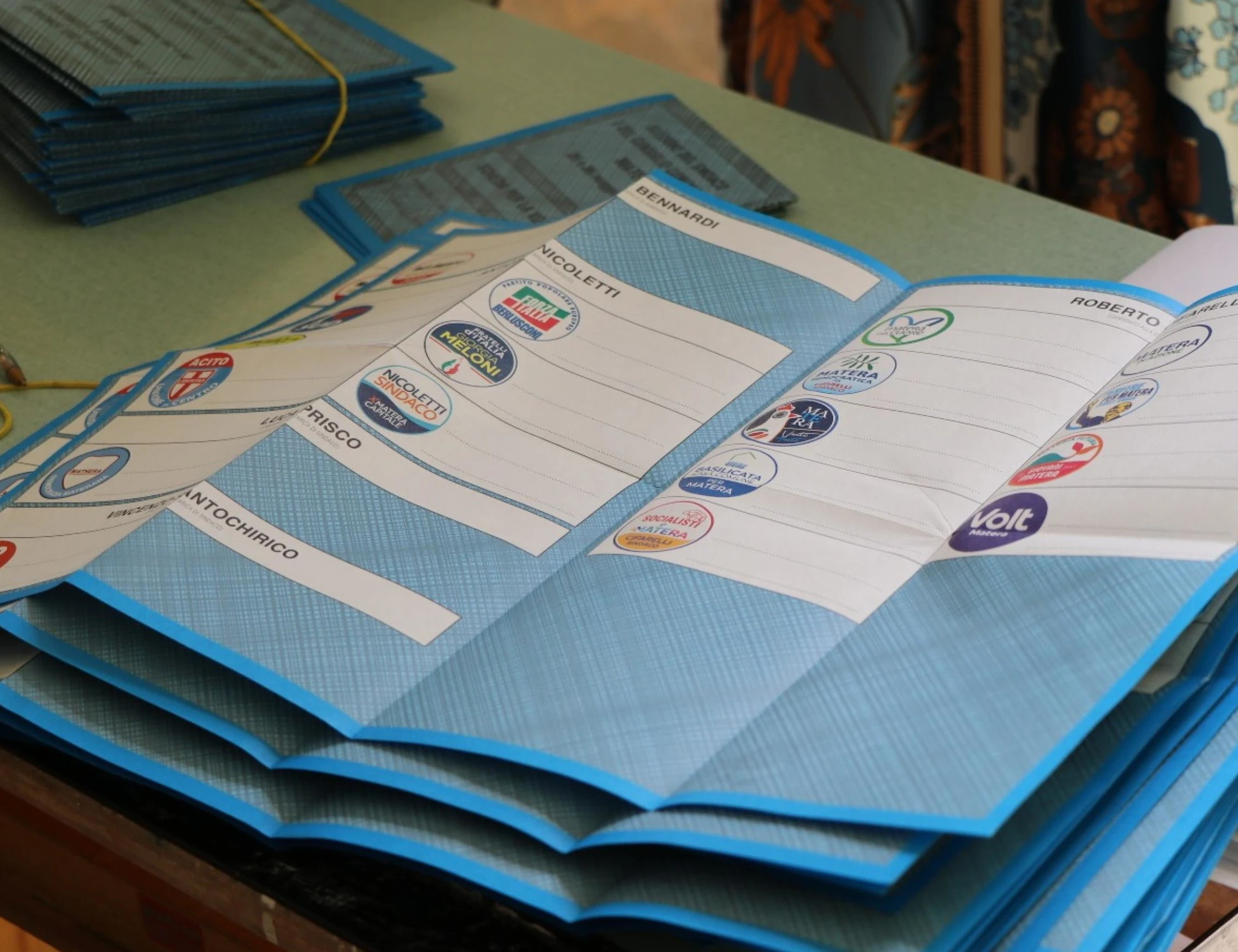La partecipazione politica in Italia, ma in genere in tutte le democrazie occidentali, è in calo netto costante. La ricerca appena pubblicata dall’Istat è impietosa. Nel nostro Paese, che pure un tempo si segnalava per un tasso di partecipazione superiore a molti altri del nostro continente, nel 2024 si è registrato un calo del 13% fra gli uomini e più contenuto ma comunque rilevante fra le donne (6%). Il dato in sé non deve portare a facili conclusioni o implicazioni: se per partecipazione politica di intende aderire a un partito, partecipare a manifestazione, o cose del genere, per un liberale non è un male in sé. Potrebbe trattarsi anche di una scelta consapevole, fatta o perché l’offerta politica risulta insufficiente o perché si vuole dimostrare una qualche forma di insoddisfazione.
Non è un caso che le democrazie occidentali, a cominciare da quella americana, si siano caratterizzate sempre per un indice non elevatissimo di partecipazione alla politica in senso attivo, al contrario degli stati autoritari e plebiscitari. D’altronde, l’epoca della “mobilitazione delle masse”, permanente e intensa, è finita da un bel po’ e non è detto che non sia un male. Se però si va più a fondo nella ricerca dell’Istat si scoprono alcuni dati che fanno cambiare un po’ la prospettiva.
Ad esempio, fra gli under 24 addirittura un giovane su due non si informa proprio dei fatti politici, ritenendoli praticamente insignificanti per la propria vita. Il che denota praticamente due atteggiamenti: o di un atteggiamento di chiusura verso il mondo e la società, in un narcisistico compiacimento di sé stessi e del proprio particolare, o una profonda ignoranza delle dinamiche che reggono la società e la vita. In questo secondo caso, si potrebbe spiegare in questo senso l’adesione del tutto irrazionale di tanti giovani a rivendicazioni tipo quelle pro-Pal o di un certo ambientalismo strumentale.
I giovani in risto caso possono facilmente diventare preda di accorti imprenditori della politica che si servono per i loro scopi delle emozioni e delle suggestioni che hanno manipolandole a proprio piacimento. È qui che il tema della scarsa partecipazione si collega con quello della qualità delle nostre democrazie, che è tema serio e su cui riflettere. Ed è qui che il richiamo all’esercizio dello spirito critico, a partire dall’educazione scolastica, diventa imprescindibile. Non si tratta tanto di invocare una partecipazione comunque sia, ma di cercare una partecipazione consapevole alla vita sociale oltreché politica. Ecco forse perché l’assassinio di Charles Kirk ha addolorato particolarmente: egli cercava il dialogo, usando quel “metodo socratico” basato sull’argomentazione razionale che è la quintessenza della democrazia. Chi a sinistra non lo capisce o è a sua volta, etimologicamente, ignorante o è in malafede. La partecipazione politica è molto differenziata sul territorio. Si informa di politica almeno una volta a settimana la maggioranza della popolazione del Centro-nord (con valori compresi tra il 52 e il 54%), contro il 40% circa del Mezzogiorno. Sempre nelle regioni del Mezzogiorno una quota analoga (37,3%) non si informa mai a fronte del 25% circa delle regioni del Nord. In particolare Calabria, Sicilia e Campania presentano i livelli più bassi di partecipazione collocandosi ai primi posti per numero di uomini e donne che non si informano e non parlano mai © RIPRODUZIONE RISERVATA di politica.