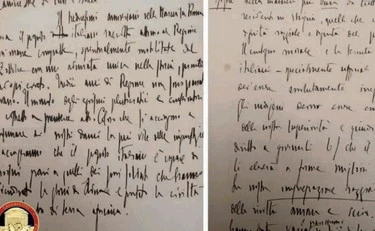Il nuovo romanzo di Pierre Jourde è un libro che attraversa la montagna, intesa come esperienza limite e spazio di sottrazione. Tutto accade in Alvernia – regione del massiccio centrale francese – ma le parole non coincidono con un’identità geografica riconoscibile. Jourde, autore francese scomodo e controcorrente, rivela il cuore vuoto della Francia in cui le carte geografiche si schiariscono fino al bianco, come se mancassero le parole per coglierlo nella sua essenza. È proprio da quel bianco iniziale che prende forma la natura antropologica del libro, segnando un tempo sospeso in cui perdersi.
Dalla montagna perduta (pubblicato da Prehistorica Editore, tradotto da Silvia Turato pp.180 €17) si muove tra osservazione topografica e meditazione filosofica. La montagna di Jourde non è mai rifugio, piuttosto, è un non-luogo radicale. Il “Ciclo della montagna” – composto da Paese perduto, Il Tibet in tre semplici passi, La Prima pietra e Il Viaggio del divano letto – prosegue con un centro vuoto intorno al quale tutto si organizza e si disfa, senza soluzione di continuità.
La valle dei dinosauri nel parco dello Stelvio: "Migliaia di esemplari"
Una scoperta sensazionale nel cuore delle Alpi lombarde destinata a ridefinire la conoscenza sui dinosauri in Italia, ch...Ma se il bianco è la soglia, il nero è la materia. Jourde – già vincitore del Grand Prix De L’Académie Française - insiste su una cromia scura che impregna i muri e le stalle, persino il latte delle mucche che rende tanto orgogliosi gli allevatori transalpini, sembra avere un residuo d’ombra indelebile. Non si tratta di simbolismo, ma di una percezione fisica che resta sulla pagina: il paesaggio dell’Alvernia non si offre allo sguardo, lo trattiene. La montagna costringe chi la attraversa a fare i conti con l’opacità del reale, con ciò che sfugge all’identità lineare.
Il vero asse del libro è un rapporto dialettico mai risolto che chiama in causa il lettore. Il paesaggio è assenza: altipiani spogli, sentieri che si perdono nel muschio, villaggi che sembrano emergere solo per un attimo da un interminabile inverno, avvolti dalla bruma. Ma è, al contempo, anche presenza: il letame e il clangore dei bidoni del latte, fra gesti ripetuti e figure marginali. Le due dimensioni si compenetrano fino a diventare indistinguibili.
È in questa oscillazione che Jourde colloca l’esperienza totalizzante della sua montagna: perdersi – scrive Jourde – è la sua essenza ma non v’è nulla di consolatorio, nulla che evochi l’atmosfera delle comunità neorurali di cui tanto si parla. Difatti, la parte finale del libro sposta l’asse narrativo su un piano che dilania ogni stereotipo. Le case diventano organismi abitati da presenze ambigue; la genealogia familiare è intrisa di segreti che non possono essere rivelati. In questo scenario, la memoria non trova requie e l’infanzia, lungi dall’essere un eden perduto, è il primo non-luogo, uno spazio di paure, desideri e immagini che ritornano senza alcuna possibile consolazione.
Una pagina via l’altra, Dalla montagna perduta di Jourde si rivela un trattato poetico sull’esilio interiore. La montagna insegna l’estraneità, non l’appartenenza; mostra che la bellezza è un accadimento fragile, in cui il ritorno alle origini si rivela impossibile. La scrittura – ironica, lirica, caustica – non ci salva dall’inevitabile ma ci permette di sfiorarlo mentre svanisce. Ed è forse questo il gesto più radicale del libro: abitare il vuoto senza colmarlo, voler dare forma all’assenza senza redimerla, accettare che proprio lì, in quello spazio bianco in cui l’osservatore distratto non vede nulla, proprio lì si trova qualcosa di essenziale e al contempo, intangibile ed effimero che rivela chi siamo.