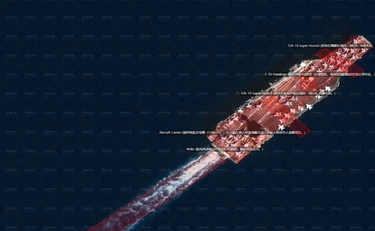Esistono due mondi e due epoche storiche: prima e dopo la bomba atomica. Prima, c’è la minaccia di un esercito potente, la capacità di manovra e sorpresa, il mestiere delle armi; dopo, c’è il fungo dell’esplosione, l’impatto del fuoco e delle radiazioni, la teoria del primo lancio e (forse) della risposta, il concetto di deterrenza nucleare. Prima, c’è il generale prussiano Carl von Clausewitz; dopo, ci sono le idee e l’azione del Consigliere per la Sicurezza nazionale e Segretario di Stato Henry Kissinger.
Nel vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin c’è sul tavolo una guerra in Ucraina condotta con le armi del “prima”, ma tutto si svolge all’ombra del “dopo”, dei missili armati di testata atomica. In Alaska, servita sul ghiaccio, c’è la bomba atomica, l’arma del club nucleare al quale sono iscritti nove Stati: Russia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Corea del Nord e Israele. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Sipri di Stoccolma, l’arsenale globale è pari a 12.241 testate, oltre 9 mila sono pronte all’uso, 3.912 sono trasportate da missili e aerei, tra queste, 2100 sono piazzate su missili balistici in stato di allerta, quasi tutti collegati al pulsante rosso di Mosca e Washington. Ecco dunque il “dopo” diventa “adesso”, siamo sempre sul punto al quale giunsero gli scienziati che costruirono la bomba atomica che poi fu sganciata dagli americani su Hiroshima e Nagasaki 80 anni fa. Non sono fatti lontani, è la storia che continua a dispiegarsi a ondate sul presente.
Questo eterno ritorno della storia rimbalza sulle pagine dei giornali sotto forma di segnale debole, spesso è cabaret intellettuale: in Italia sulla partecipazione di Enrico Fermi al progetto di costruzione della bomba atomica si è aperta una polemica innescata da un intervento a gamba tesa del fisico Carlo Rovelli contro lo scienziato che guidò la leggendaria Scuola di Fisica di Via Panisperna. Rovelli ha un punto di vista da pacifista totalitario, si precipita in una grezza polemica contro un gigante come Fermi che, con tutto il rispetto, lo avrebbe fatto evaporare con uno scarabocchio. Il rovello del Rovelli, il baco nel software del suo ragionamento, lo illumina con eleganza su Libero una scienziata, una fisica e grande divulgatrice, Gabriella Greison. Attenzione, questo non è un esercizio intellettuale, tanto meno è una baruffa accademica, sopra e sotto questa storia c’è la politica al più alto livello, una storia di urgente attualità perché è l’argomento da salotto a volte facoltoso e sempre incolto è già pronto ad atterrare nei prossimi cortei mediatici dell’autunno, rigorosamente dopo le vacanze sullo yacht (di qualcun altro, quello che paga). Non è un caso che questo scontro sul ruolo degli scienziati nei conflitti si sia riacceso, perché il problema nucleare è aperto: Israele ha colpito gli scienziati che hanno sviluppato il progetto atomico dell’Iran e ha ricordato che quelli che sono sopravvissuti sono «morti che camminano»; la Corea del Nord e la sua macchina militare sono una minaccia atomica nelle mani di un dittatore imprevedibile come Kim Jong-Un (che guarda caso Putin ha chiamato al telefono prima dell’incontro di oggi con Trump); le tensioni tra India e Pakistan risvegliano fantasmi radioattivi tra il Gange e l’Himalaya; Emmanuel Macron, «en passant», dice che può mettere a disposizione degli alleati europei la Bomba francese, come se fosse un assaggio all’ora di un «apéritif»; il dottor Stranamore della Russia, Dmitry Medvedev, afferma che «il nucleare non è un bluff»; e Trump che gli risponde spostando due sottomarini al largo della Russia. Non è la crisi del 1962, quella dei missili russi a Cuba puntati sugli Stati Uniti, ma ci sono elementi sufficienti per non dormire tranquilli la notte.
La politica - questo è il punto su cui Rovelli e i pacifisti scivolano tragicamente - è sempre spiazzata dal balzo tecnologico, anche quando lo guida come nel caso del progetto Manhattan. Quando il “fatto nuovo” si presenta (la bomba atomica di Oppenheimer, Fermi e altri grandi menti dell’epoca), la scoperta delle proprietà e capacità dell’atomo diventa un’invenzione e il suo significato viene scritto dal contesto storico (la Seconda guerra mondiale, la corsa di Hitler al nucleare e la carneficina degli americani contro il Giappone nel Pacifico). Cosa sarebbe successo se non ci fosse stata Pearl Harbour? E se Hitler avesse raggiunto per primo l’obiettivo di costruire la Bomba? Saremmo in un’ucronia, un magnifico genere letterario che spesso ha anticipato i nostri peggiori incubi. Non in questo caso, ma ci siamo andati più vicino di quanto pensino i Rovelli di varia estrazione. Il tema è emerso in superficie come un sottomarino tra i ghiacci, quando ieri Vladimir Putin ha detto che la Russia vuol discutere con gli Stati Uniti di un nuovo accordo sulle armi nucleari. Chiunque comprende che si tratta di una questione fondamentale per la sicurezza europea: i missili della Nato puntano sulla Russia, che a sua volta punta sulle capitali e gli obiettivi strategici del Vecchio Continente, l’obiettivo più vicino alle basi di lancio di Mosca. L’Europa ha vissuto 80 anni di pace grazie all’idea di deterrenza atomica, all’equilibrio della paura, il sapere che in una guerra nucleare non ci sono vincitori. Il fatto nuovo è che il conflitto in Ucraina e il taglio della linea del “telefono rosso” tra Washington e Mosca ha cambiato lo scenario e i trattati sui missili sono poco più che carta diplomatica. Tutti riconoscono il rischio elevato, ma gli Stati Uniti e la Russia oggi sono in una terra di mezzo dove tutto è possibile. Mosca alla fine del 2024 ha rivisto le basi della sua dottrina abbassando la soglia nucleare, la “risposta” del Cremlino oggi scatta anche sulla base di un allarme (nel linguaggio militare, «launch on warning», LOW) che comprende anche un attacco in cui il nemico «usando armi convenzionali, crea una minaccia critica alla nostra sovranità». Cosa è la «minaccia critica»? Non si sa, come d’altronde non conosciamo i protocolli che attivano il pulsante nucleare degli Stati Uniti, le cui linee guida sembrano più restrittive. Trump e Putin oggi devono parlare di questo scenario, è legato all’Ucraina, lo precede storicamente, lo segue nella sua disgregazione e lo supera nelle conseguenze.