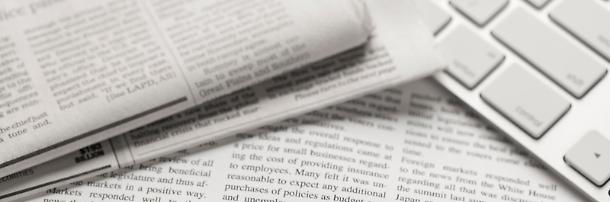In settimana la Bbc ha pubblicato sul proprio sito Internet una ricetta della pasta cacio e pepe che ha scatenato il putiferio. Quattro ingredienti invece di tre: spaghetti, pepe, parmigiano e burro. E il parmigiano al posto del pecorino. Roba da far drizzare i capelli in testa a chiunque abbia un minimo di familiarità con la vera cucina italiana. Non a caso, lo strafalcione gastronomico ha provocato una levata di scudi da parte dei ristoratori e delle associazioni di categoria italiane. Con la richiesta formale di rettifica e l’intervento, simbolico ma efficace del corpo diplomatico. Non bastasse il caso internazionale ci si è messo pure il professor Alessandro Barbero, storico, saggista e personaggio pubblico, apprezzato soprattutto a sinistra, che ha rilanciato sui social media un’intervista rilasciata lo scorso anno al Gambero Rosso, durante il festival gastronomico Baccanale di Imola. «Una cucina nazionale italiana non esiste», disse il docente ex Pci, «esiste solo fra gli italo americani i quali mangiano spaghetti with meatballs e gli americani credono che quella sia la cucina italiana». Salvo ammettere, nell’intervista, che «la nostra cucina è un insieme di innumerevoli cucine» regionali e locali. Ma questa aggiunta Barbero non l’ha condivisa sui social. Chissà perché. Resta il fatto che a differenza di vegetali, formaggi, salumi e insaccati che possono mettere in campo la difesa delle Denominazioni d’origine protette (Dop) e delle Indicazioni geografiche protette (Igp), le ricette caratteristiche della nostra tradizione alimentare non hanno alcuna tutela efficace. E al momento chiunque, in ogni parte del mondo, può scimmiottarle e modificarle a piacere. Salvo fare una pessima figura, com’è accaduto alla Bbc.
CERTIFICAZIONE UE
A livello europeo, per proteggere le ricette tradizionali esiste una certificazione dedicata, la Stg, Specialità tradizionale garantita, un marchio che tutela il metodo di produzione piuttosto che l’origine geografica. L'Italia ha ottenuto finora solo quattro riconoscimenti Stg, per mozzarella, Pizza napoletana, amatriciana tradizionale e, dal 2022, per i vincisgrassi alla maceratese. Niente carbonara, niente cacio e pepe. E neppure risotto alla milanese, pici all’aglione, ragù alla bolognese. L’unico limite per i taroccatori è in realtà la loro conoscenza a dir poco approssimativa della cucina italiana e delle sue preparazioni. Per ottenere la certificazione di Specialità tradizionale garantita, un prodotto agroalimentare o una ricetta deve essere ottenuto secondo un metodo di produzione tipico tradizionale, con almeno 30 annidi comprovata esistenza, ma non necessariamente legato ad una specifica area geografica. Il processo produttivo deve essere dettagliato in un disciplinare, che include il nome del prodotto, la sua descrizione, il metodo di produzione, e gli elementi che ne attestino il carattere tradizionale. L’esistenza trentennale, nelle intenzioni dei legislatori europei, dovrebbe testimoniare il passaggio dalla generazione che ha concepito la Stg per lo meno a quella successiva. Fra l’altro, di recente, la Commissione europea ha introdotto per le Stg la riserva del nome obbligatoria, un dettaglio fondamentale. Mentre prima era possibile commercializzare una imitazione delle Stg che non rispettasse il disciplinare, a condizione di non utilizzare il marchio giallo-blu delle Specialità tradizionali garantire, ora non si può più farlo. Per lo meno nei 27 Paesi della Ue. Ad esempio la pizza napoletana che non rispetti il disciplinare della Pizza napoletana Stg potrebbe essere sanzionata se le autorità preposte al controllo e alla tutela delle indicazioni geografiche applicassero i regolamenti Ue. Ma questa è un’altra storia che ho già raccontato su Spesa Libera. Incredibilmente, nonostante l’Italia sia il Paese Ue con il più alto numero di indicazioni geografiche, ben 893, siamo superati da altri Paesi nelle Stg. Mentre noi siamo fermi a quattro, la Polonia ad esempio ne ha dieci, anche se è stata formalizzata la richiesta per la bistecca alla fiorentina.
CANDIDATI IDEALI
Secondo un documento largamente incompleto - che è rimbalzato a lungo fra gli organismi di settore per poi finire nel dimenticatoio, sarebbero oltre una trentina le ricette con i numeri per aspirare alla Stg.
Di queste almeno dieci avrebbero un’altissima probabilità di passare il vaglio della Commissione europea ed ottenere il bollino giallo-blu. Purtroppo ben pochi hanno compreso il valore simbolico di protezione dalle imitazioni che la Stg offrirebbe perfino al di fuori della Ue. Così i soggetti potenzialmente interessati a inoltrare la domanda a Bruxelles non lo hanno mai fatto. In base ai regolamenti Ue la domanda per la Stg può essere presentata da un’associazione di produttori, un gruppo di operatori del settore, perfino da un singolo ristoratore che operi nel rispetto di un disciplinare. Come ho già chiarito è necessario che il prodotto agroalimentare, in questo caso la ricetta, sia ottenuto secondo metodi di produzione tradizionali, e che questa tradizione sia riconosciuta e documentata. Da un punto di vista pratico servono: atto costitutivo dell'associazione, disciplinare di produzione, relazione storica, relazione tecnico-economica, marchio per l'etichettatura. L’iter può durare anni e i costi sono interamente a carico degli operatori. All'estero intanto prosperano le imitazioni. Carbonara con panna in Belgio, guanciale sostituito con bacon nei paesi anglosassoni. Per non parlare degli ingredienti come il romano cheese fatto con latte di mucca invece del pecorino romano. Negli Stati Uniti. Secondo un’analisi Coldiretti, più di un turista italiano su due si è imbattuto in versioni distorte delle ricette italiane. Il mercato dei piatti taroccati nel mondo, inclusi i falsi ingredienti italiani, vale circa 40 miliardi di euro.
CODICE DEL GUSTO
Ma a prescindere dalle radici storiche che affondano per lo meno nel tardo Medioevo in realtà la cucina italiana e i suoi piatti della tradizione possono contare su una unicità che deriva loro da accostamenti di ingredienti e sapori che non hanno eguali al mondo. Per semplificare esiste un codice del gusto che rende unica e irripetibile la nostra cucina e la distingue radicalmente, ad esempio, da quella francese, tedesca o britannica. Albert-László Barabási, fisico ungherese originario della Transilvania, ha mappato le relazioni tra ingredienti creando il flavor network - la rete del sapore. Analizzando 56.498 ricette da tutto il mondo, ha fatto una scoperta inattesa: la cucina italiana appartiene alle cucine dell’Europa meridionale, un gruppo che segue regole diverse dal resto d'Occidente e diversissime pure da quelle del nord Africa. Mentre francesi del nord, tedeschi e americani abbinano ingredienti che condividono molecole aromatiche - burro e panna, vaniglia e cioccolato, nocciola e caramello- gli italiani fanno l’opposto. Preferiscono il contrasto molecolare, esattamente come le cucine asiatiche. Pomodoro e basilico, l’abbinamento più italiano che esista, non condividono quasi nessun composto aromatico. Eppure funzionano perfettamente. La pastasciutta - pasta scolata e mantecata con sughi che non esistono da nessun'altra parte al mondo- crea matrimoni impensabili: l’amido della pasta con l’acidità del pomodoro, la cremosità del parmigiano con la piccantezza del pepe. I risotti dell’Italia settentrionale trasformano un cereale in velluto attraverso la tecnica della mantecatura, sposando il riso con ingredienti che molecolarmente non dovrebbero funzionare: zafferano e midollo, radicchio e gorgonzola, zucca e amaretti. È questo codice del gusto non scritto ma saldamente radicato nei composti aromatici dei cibi che mangiamo a disegnare i contorni che rendono irripetibile e unica la nostra cucina.