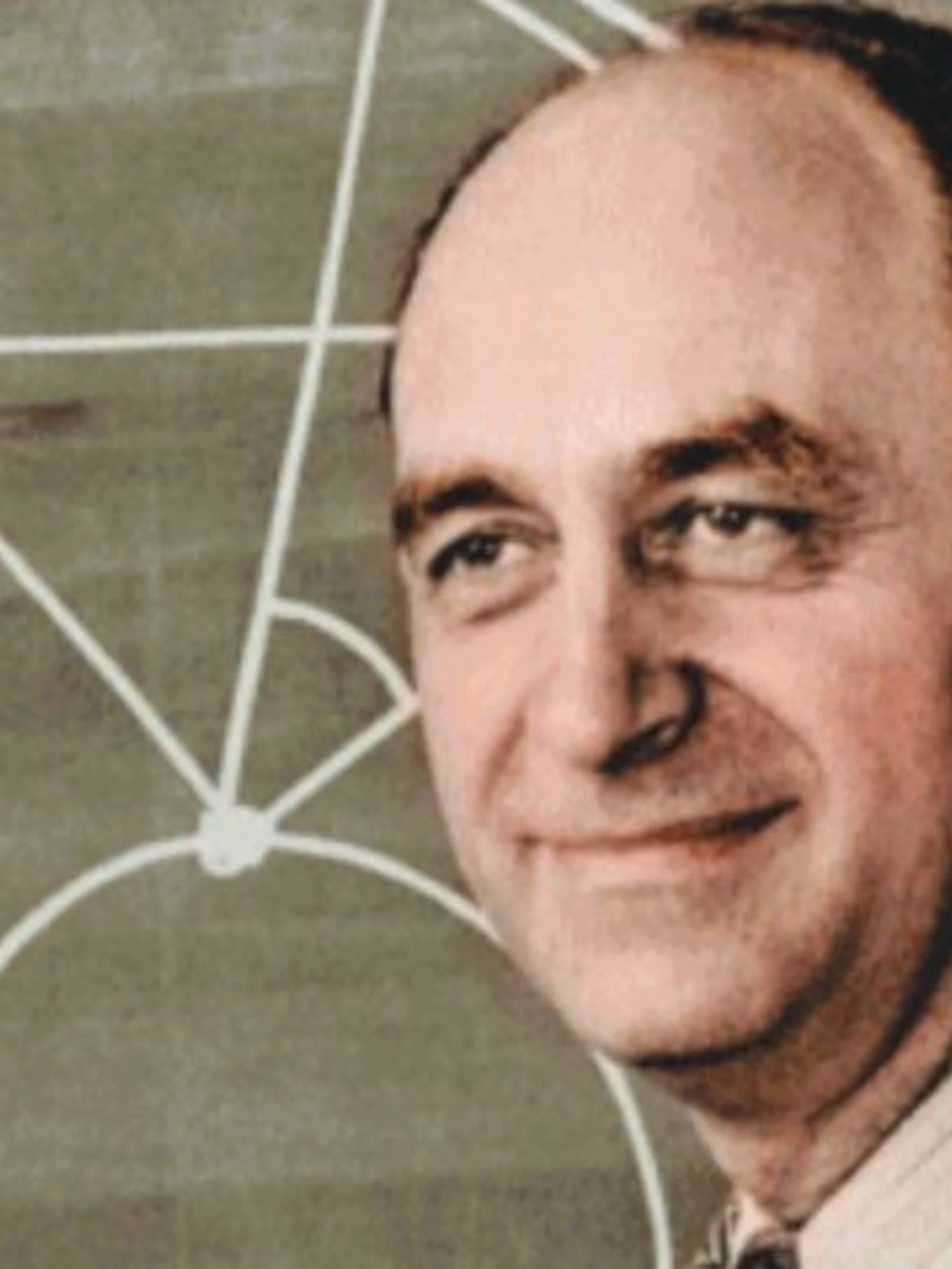Che meraviglia, la fisica italiana: quando non siamo impegnati a spiegare l’universo, troviamo sempre un momento per spaccarci l’atomo... tra di noi. Da una parte Carlo Rovelli, che in un episodio della serie del Corriere della Sera “La bomba atomica” sembra dipingere Enrico Fermi come il cattivo di un film di guerra. Dall’altra Angela Bracco, presidente della Società Italiana di Fisica, che lo difende come fosse San Enrico Martire della Reazione a Neutroni. E in mezzo il pubblico: attonito, per le due versioni inconciliabili. La verità, come spesso accade in fisica e in storia, non sta in un like o in un titolo ad effetto: Fermi era un genio, ha avuto un ruolo chiave nel “Progetto Manhattan”, il programma americano di ricerca che portò alla realizzazione delle prime bombe atomiche durante la seconda guerra mondiale. In questo senso, ha visto la fisica correre più veloce della coscienza - e tutto questo si può raccontare senza trasformarlo né in eroe di marmo né in villain assetato di plutonio. Altrimenti finiamo a discutere se il frac di Stoccolma fosse resistenza, invece di chiederci come raccontare il nucleare ai ragazzi senza propaganda. Nel capitolo “1934 Enrico Fermi” della serie del Corriere, Rovelli presenta un ritratto cupo dello scienziato. Il tono, narrativo ma tagliente, ha scatenato la replica indignata di Bracco: «Screditato e infangato», accusa, ricordando i contributi di Fermi e il contesto dell’epoca.
La verità è che Fermi è una figura fuori scala: Premio Nobel nel 1938, guida dei “ragazzi di via Panisperna”, inventore della tecnica dei neutroni lenti, padre dell’interazione debole. Nel ’38 lascia l’Italia a causa delle leggi razziali (sua moglie era ebrea), va negli Stati Uniti e nel ’42 guida la prima reazione nucleare controllata. Sì, partecipa al “Manhattan Project”. Ma ridurlo a un “ingegnere della morte” è miope: il nazismo incombe e la corsa all’arma sembra necessaria. Il problema è la narrazione polarizzata: in Italia trasformiamo figure complesse in figurine da album - santi in processione o mostri col camice insanguinato. E il nucleare? Da noi è come urlare “squalo!” in piscina: panico immediato. Invece significa anche radioterapia, diagnostica, isotopi per la ricerca, energia a basse emissioni. Ridurre tutto a Hiroshima e Nagasaki è amputare la storia. Resta il nodo morale: uno scienziato è responsabile delle applicazioni della sua scoperta? Oppenheimer cita la Bhagavadgita, Bohr predica il dialogo, Szilárd prova a frenare con una petizione, Compton la presenta a Truman: chiede lo sgancio della bomba in mare aperto. Fermi pare non abbia firmato quella petizione, ma non si sa con precisione, il “Progetto Manhattan” è tra i segreti meglio custoditi della storia dell'umanità. Giudicarlo oggi significa falsare contesto e conseguenze. E qui entra la questione di come si racconta la scienza: si può fare arte, mescolare rigore e creatività, portare il pubblico dentro le sfumature senza spegnerle.
Oppure si può entrare a gamba tesa, schierarsi come in curva sud e ridurre tutto a due fazioni che si urlano addosso. Il primo modo apre le teste, il secondo le chiude ancora di più. Perché ridurre Fermi a frasi a effetto è come raccontare la Luna parlando solo del costo del biglietto per andarci: fa sorridere, ma non serve a capire niente. E poi c’è la parentesi più interessante: 1934, Fermi bombarda l’uranio con neutroni e interpreta i risultati pensando a elementi “più pesanti”, i famosi transuranici. Ida Noddack — sì, una chimica tedesca che legge con attenzione tutto — pubblica un commento audace: forse il nucleo non diventa solo un po’ più grosso, forse si spezza in pezzi grandi. Non fa l’esperimento e la comunità non la segue: è un lampo teorico fuori schema. Quattro anni dopo, a Berlino, Otto Hahn e Fritz Strassmann trovano bario dopo l’irraggiamento dell’uranio. Lise Meitner, in esilio, fa i conti con Otto Robert Frisch e dà il nome giusto: “fissione”. In mezzo, la parte più interessante: come procede la scienza. Non per titoli di giornale, ma per tentativi, ipotesi borderline, intuizioni che non tornano finché qualcuno non trova un modo elegante per farle tornare comprensibili. Senza Noddack e senza Meitner, il nostro racconto del ’34 sarebbe un’altra favola semplificata. Concludendo, se vogliamo onorare Fermi, dobbiamo raccontarlo senza paura della complessità. I grandi della scienza non vivono in bianco e nero, ma in un caleidoscopio di contraddizioni. Perché in laboratorio non esistono santi o demoni: esistono solo idee, esperimenti, e quelle maledette domande che restano quando l’esperimento è finito. E, a differenza dei neutroni lenti che tanto amava studiare lui, noi fisici non possiamo permetterci di rallentare il pensiero critico...perché qui, se rallenti, spunta subito qualcuno pronto a “spiegarti” la fisica, fresco di mezz’ora su Wikipedia.