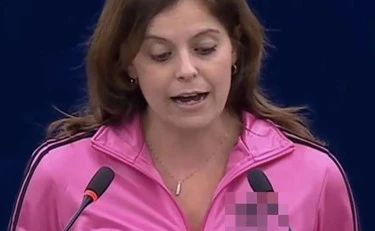Una delle vette della poesia latina è notoriamente, il De rerum natura di Lucrezio. Nel poema, l’autore (che la tradizione vuole morto suicida, in preda alla follia per le conseguenze di un filtro d’amore) presenta il mondo e il cosmo come frutto di una casuale aggregazione di atomi, senza una provvidenza benevola né una qualche divinità che si occupi dei mortali. Invece, il De rerum naturis di Rabano Mauro, secoli dopo, ci offre la visione di un universo provvidenzialmente ordinato per volontà divina. Di questa enciclopedia medievale, meritoriamente Claudia Gualdana dà ora una traduzione con ricca introduzione in Rabano Mauro, Il mondo e gli astri (De rerum naturis, libro IX), edita da La Vita Felice (160 pp., 12 euro) Rabano Mauro, nato attorno al 780, era un monaco e amava vivere nel silenzio: era uno di quei personaggi singolari oggi del tutto fuori moda e proprio per questo interessante. Potremmo però considerarlo una bussola per chi volesse scampare alle ubriacature ideologiche di questo nostro tempo disorientato. Lo si immagina intento a leggere nella quiete di una biblioteca più che vetusta, o raccolto in preghiera in una chiesa, da qualche parte in Germania.
ORA ET LABORA
Della sua vita, del resto, si sa poco, in onore alla sobrietà e al riserbo monastici: possiamo solo ipotizzare come si svolgessero le sue giornate di benedettino, ordine il cui motto notoriamente è ora et labora. Nacque da una famiglia nobile di origine franca della città di Magonza, alla confluenza dei fiumi Reno e Meno, e i suoi genitori lo offrirono bambino al monastero di Fulda, in Assia, dove fu consacrato diacono intorno all’802 per poi essere mandato a studiare a Tours, in Francia, sotto la guida del filosofo e teologo anglosassone Alcuino di York. È invece precisa la data di morte, il 4 febbraio 856, giorno della sua memoria liturgica, perché Hrabanus Maurus Magnentius – tale il suo nome latino – è un santo cattolico, anche detto Praeceptor Germaniae, ovvero “precettore” di quelle terre. Il De rerum naturis è una enciclopedia, intesa non alla maniera moderna, come facciamo da Diderot e D’Alembert in poi; è, invece, un testo pensato per una platea di lettori potenzialmente vasta, ma soprattutto per i monaci, con l’intenzione di trasmettere il maggior numero possibile di nozioni e conoscenze sul mondo, dagli usi degli uomini ai metalli, passando per gli oceani e le stelle, ma con un intento spirituale a sostenere l’opera.
L'antieroismo trionfante dell’uomo tigre d'Africa
Se vi sentite orfani dei grandi romanzi di Salgari, e provate nostalgia per i pomeriggi passati, da ragazzi, calati nell...È scritto in una prosa divulgativa, a tratti segnata dall’urgenza, come se Rabano, ormai anziano, temesse di non riuscire a terminarla. Invece siamo di fronte a un capolavoro, dal linguaggio piano e accessibile, che proprio per queste caratteristiche si presta a essere tradotto senza essere tradito troppo. Del magistero di Alcuino di York, suo maestro, Rabano conserva in primis il concetto di sapientia, secondo il quale le arti liberali sono gradini di una scala che sale verso la conoscenza biblica: la scienza di Dio, in altre parole, sta al di sopra di ogni altra. Il percorso di Rabano segue questa via, in un ritiro contemplativo stretto tra esegesi e mistica. Il De rerum naturis o De Universo, e nello specifico, il capitolo IX, oggetto del presente volume, che la curatrice ha intitolato Il mondo e gli astri, descrive l’universo, ma anche i fenomeni atmosferici e i corpi celesti: ci troviamo di fronte a una cosmologia, come tutte le enciclopedie medievali, ovvero una descrizione della realtà nel quadro di una visione unitaria del mondo. Cimentandosi in questo genere, Rabano andava ad aggiungersi a illustri predecessori: Marziano Capella con Le nozze di Filologia e Mercurio, il filosofo e teologo Severino Boezio con il De consolatione philosophiae, Isidoro di Siviglia con le Etimologie, Cassiodoro con le Istituzioni.
SEGNO E ALLEGORIA
Il De rerum naturis è la descrizione di un universo in cui tutto è segno e allegoria di una realtà superiore: quindi, giusto per fare un esempio, Lucifero, il cui nome significa lucemfero, il portatore di luce, o stella del mattino raffigura la luce della perfetta conoscenza. Nel volto della luna, invece, vedremo l’immagine della Chiesa, ma anche delle avversità del mondo. Si tratta di un testo, come vedrete, di grande bellezza e di grande ricchezza: per cui continuiamo ovviamente a leggere quel gigante della Poesia che è Lucrezio, ma, sullo scaffale della libreria, accanto al suo poema sistemiamo questa meritoria edizione di Rabano Mauro, il suo contraltare medievale.