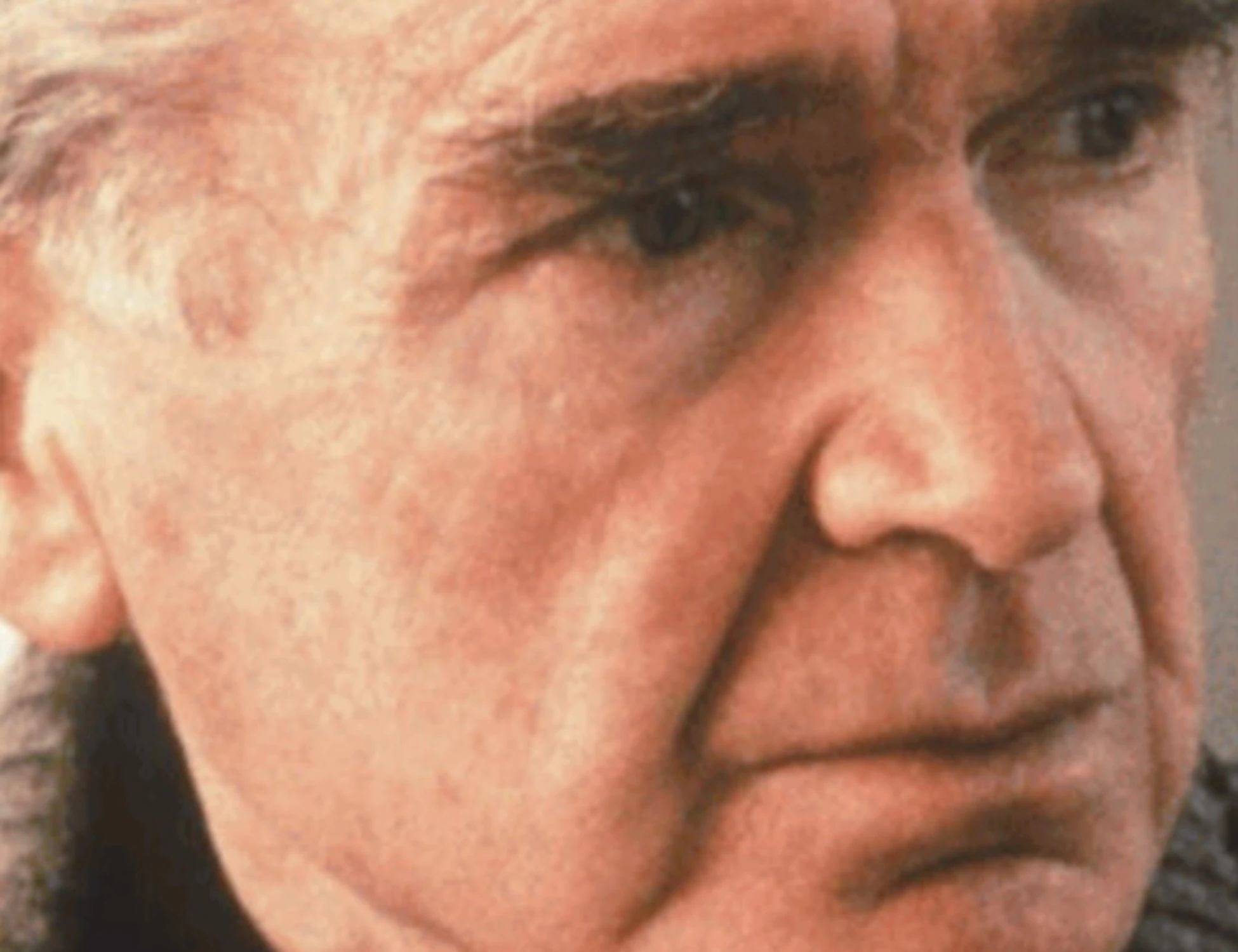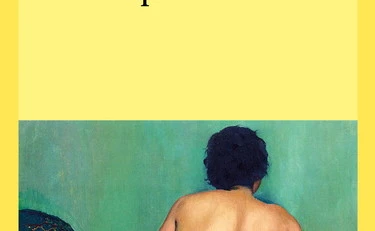Per gentile concessione dell’editore Adelphi pubblichiamo l’estratto «La facoltà di sperare» del libro «Esercizi negativi». In margine a «sommario di decomposizione» di Emil Cioran (a cura di Ingrid Astier, traduzione di Cristina Fantechi). I testi qui raccolti, tutti inediti, ci offronoil privilegio raro di penetrare nel laboratorio di Cioran e di assistere, per così dire in presa diretta, al distillarsi del suo pensiero.
Scopriamo così come il Cioran degli inizi, più lirico, più «scarmigliato », «più apertamente provocatorio», arrivi alla folgorante condensazione del frammento. «Esercizi negativi mostranol’“esplosione” vissuta e il lento lavoro di rifinitura dello stile», osserva la curatrice Ingrid Astier, e basterà scorrere anche solo i titoli di alcuni capitoli - «L’assoluto e le sue caricature», «L’improbabile come salvezza», «Il suicidio come strumento di conoscenza»,
«Tra Dio e il verme», «Del solo modo di sopportare gli uomini» - per cogliere la forza dirompente di un libro dal quale non si esce indenni. Perché «un libro deve frugare nelle ferite, anzi deve provocarle. Un libro deve essere un pericolo», affermerà molti anni più tardi lo stesso Cioran, svelando l’intento profondo di queste pagine, che alla minaccia dell’accecamento preferiscono la lucidità dell’insonnia. Adelphi pubblica le opere di E.M. Cioran (1911-1995) da oltre quarant’anni; il volume più recente è «Il crepuscolo dei pensieri» (2024).
La speranza non è un risultato della nostra esistenza, bensì la nostra stessa esistenza. Una disperazione assoluta è non solo incompatibile con il nostro essere in quanto tale, ma è inconcepibile in qualunque forma di vita. Il diavolo stesso spera: un po’ più di male, un po’ più di lucidità.Poiché sperare in negativo è ancora speranza. E l’inferno, dal momento che vi si conserva la memoria, è tollerabile solo grazie al ricordo delle speranze passate, che alleviano una dannazione senza via di uscita: pertanto l’iscrizione dantesca è lungi dall’essere del tutto vera.
La chiave del nostro destino è dunque questo impulso irrefrenabile che, in qualsiasi circostanza, ci induce a credere che tutto sia ancora possibile, malgrado gli ostacoli insormontabili e le prove senza appello. Quand’anche arrivassimo a certezze ineccepibili, di una fredda nitidezza nel loro opporsi ai nostri desideri, il nostro cuore vi aprirebbe una breccia, da dove si insinuerebbe il dio di tutte le anime: il Possibile.
È lui che ci impedisce di vedere le cose come sono; è lui che ci rende spettatori approssimativi della nostra sorte e delle sorprese che offriamo a noi stessi. Quando tutto è perduto, eccolo qui a smentire l’irrimediabile, eccolo, nemico benevolo della nostra chiaroveggenza.
L’attività di sperare ha tuttavia dei gradi, poiché la sua sostanza è infinita solo nell’immaginazione della nostra... speranza, di questa speranza che muore e rinasce ogni giorno: instancabile produzione di errori vitali, che alla lunga indebolisce la nostra capacità di sperare senza però soffocare lo sbocciare di speranze individuali e diverse. Assuefarsi alle delusioni e compiaPer gentile concessione dell’editore Adelphi pubblichiamo l’estratto «La facoltà di sperare» del libro «Esercizi negativi». In margine a «sommario di decomposizione» di Emil Cioran (a cura di Ingrid Astier, traduzione di Cristina Fantechi). I testi qui raccolti, tutti inediti, ci offrono il privilegio raro di penetrare nel laboratorio di Cioran e di assistere, per così dire in presa diretta, al distillarsi del suo pensiero.
Scopriamo così come il Cioran degli inizi, più lirico, più «scarmigliato », «più apertamente provocatorio», arrivi alla folgorante condensazione del frammento. «Esercizi negativi mostrano l’“esplosione” vissuta e il lento lavoro di rifinitura dello stile», osserva la curatrice Ingrid Astier, e basterà scorrere anche solo i titoli di alcuni capitoli - «L’assoluto e le sue caricature», «L’improbabile come salvezza», «Il suicidio come strumento di conoscenza», «Tra Dio e il verme», «Del solo modo di sopportare gli uomini» - per cogliere la forza dirompente di un libro dal quale non si esce indenni. Perché «un libro deve frugare nelle ferite, anzi deve provocarle. Un libro deve essere un pericolo», affermerà molti anni più tardi lo stesso Cioran, svelando l’intento profondo di queste pagine, che alla minaccia dell’accecamento preferiscono la lucidità dell’insonnia. Adelphi pubblica le opere di E.M. Cioran (1911-1995) da oltre quarant’anni; il volume più recente è «Il crepuscolo dei pensieri» (2024). cersi segretamente della loro capacità seduttiva equivale a distruggere la forza di quella «faculty of hoping» di cui parlava Keats.
Così la nostra volontà di accecamento continua a sperare, attaccata a una cosa o a tutte, ma la sorgente degli abbagli si prosciuga; scorgiamo il fondo di questa fontana delle lusinghe, che i nostri occhi ormai smagati rendono limpida e senza profondità. Diventiamo come un credente che adorasse tutto – angeli, santi – tranne Dio. Possiamo nutrire più speranze di tutte le creature che sperano, ma il centro da cui queste speranze promanano perde il suo potere d’irradiazione ed esse si disperdono sulla superficie arbitraria della nostra anima. Come coordinarle, come ricondurle al loro punto di partenza e riunirle in un fascio? Sono raggi che illuminano secondo il loro capriccio tutte le nostre strade e nessuna di esse.
L’anima malata non è disperata; perché la disperazione porta a tutto; molto spesso è la prima tappa di una soluzione positiva; la disperazione ha bisogno di attività, di sacrificio, di incoscienza. La società la sfrutta- ed ecco gli eroi. (L’eroismo non è altro che una disperazione che si conclude con monumento pubblico). Il paradosso dell’anima malata è che non spera più in nulla pur abbandonandosi a tutte le speranze.
Una vitalità incerta, divorata da dubbi e da sottili lutti teorici, la spinge a questo gioco fasullo che salva le apparenze e la propria... esistenza. La riduzione della facoltà miracolosa implica una analo ga diminuzione del nostro essere: speriamo meno e siamo meno. Tuttavia viviamo proprio grazie all’incessante rinnovamento costituito dall’attività di ogni singola speranza, grazie alla fantasia del Possibile che rianima le illusioni perdute.
Possiamo vivere senza la coscienza della speranza – la fierezza intellettuale ci obbliga a farlo –, ma non possiamo vivere senza il suo dinamismo nascosto; possiamo essere stanchi di sperare, ma il lusso di un totale rifiuto del possibile costa caro ed è esiziale.
Per lo stesso motivo, la maggior parte degli uomini non crede nell’immortalità – metterebbe troppo in imbarazzo la ragione –, eppure ognuno vive come se fosse immortale. Questa immortalità inconscia è della stessa natura della facoltà di sperare. L’uomo sa che la morte è inevitabile, ma agisce come se lo ignorasse; sa che è assurdo sperare ma si comporta come se tutto il futuro gli appartenesse.
Il vero miracolo dell’esistenza non consiste affatto in qualche fenomeno insolito, ma in questo accanimento a non accettare l’impossibile benché normale, abituale – in questa ostinazione ad aspettarsi dall’attimo futuro più che dal precedente. Il miracolo dell’esistenza si richiama all’idolatria del tempo, le cui sollecitazioni sono soltanto modalità della facoltà di sperare. Anche l’infelicità si preoccupa del tempo, ma per contrastarne il corso, per opporsi al suo svolgimento.
Così l’infelice è colui che non ha trovato alcunché nell’esistenza temporale e ancora meno al di fuori o al di sopra di essa: divorandola egli si divora – mentre il disperato può benissimo rifiutarla, seppellirsi vivo nell’eternità e prosperare così in Dio.