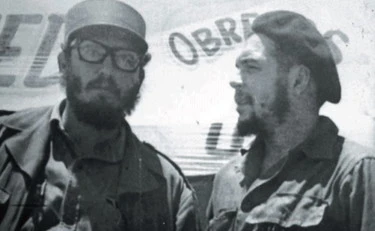Ci sono immagini che restano impresse per sempre nella nostra memoria collettiva: bambini sotto le macerie, civili inermi uccisi a sangue freddo, gli sguardi vuoti di chi ha perso tutto. Sono le scene che ci arrivano dai fronti di guerra, dagli atti di terrorismo internazionale, dai recenti massacri che hanno insanguinato il nostro tempo. E ogni volta ci chiediamo: com’è possibile che l’uomo possa essere tanto crudele, tanto spietato, tanto insensibile? La storia – quella grande, fatta di nazioni, ma anche quella piccola, quotidiana, che si consuma nelle cronache di quartiere – ci ricorda che la ferocia umana è una costante.
Dalla Shoah ai gulag sovietici, dai genocidi in Africa alle fosse comuni nei Balcani, dall’11 settembre a Mariupol, da Gaza a Bucha, la mano dell’uomo ha sempre saputo superare ogni limite, ogni legge morale, ogni residuo di pietà. Ci illudevamo che il ’900, secolo delle ideologie estreme e delle guerre mondiali, ci avesse vaccinato contro certi orrori. Che Auschwitz fosse diventata un monito indelebile. Che dire “mai più” significasse qualcosa. E invece, ogni giorno, la cronaca ci smentisce. Omicidi efferati, uxoricidi, bambini uccisi in famiglia, violenze gratuite e sadiche. Non servono nemmeno le guerre per vedere la disumanità all’opera: basta accendere la TV o scorrere i social.
Perché, nonostante l’educazione, la memoria storica, le dichiarazioni solenni, la nostra società continua a produrre violenza? La risposta non è univoca, ma alcune linee si possono tracciare. La prima è la disumanizzazione dell’altro. Che sia il nemico in guerra, l’avversario politico o religioso, persino il vicino di casa, l’essere umano viene spesso trasformato in un oggetto. Non più un individuo, ma un simbolo da abbattere. Questo processo è favorito da social che estremizzano e polarizzano, da una comunicazione che spesso semplifica, etichetta e, infine, incita all’odio. La seconda è la crescente anestesia emotiva. Siamo sommersi da immagini terribili, e questo ogni giorno. Ma quando lo shock diventa routine, si smette di provare indignazione, perfino fastidio. Le tragedie scorrono accanto a pubblicità, meme, sondaggi, talk show. Tutto si mischia. E se tutto è orrore, allora niente ci colpisce davvero. Infine, la solitudine sociale. In questo vuoto crescono la frustrazione, la rabbia, la perdita di senso. E allora, per alcuni, l’atto estremo – anche il più crudele – diventa un modo per “esistere”.
Una società può scrivere mille codici, promulgare nuove norme, inasprire le pene. Ma se non educa al valore dell’altro, se non insegna a pensare e a scegliere il bene, allora quelle leggi resteranno gusci vuoti. Non bastano i proclami. Servono cultura, esempi, l’educazione costante alla responsabilità, al senso del limite. È vero: l’uomo è capace di crudeltà inaudite, ma anche di altruismo profondo. Alla fine, la vera questione è questa: quale parte di noi scegliamo di coltivare ogni giorno? “Il tipo di libertà davvero importante comporta attenzione, consapevolezza, disciplina, impegno e capacità di preoccuparsi davvero degli altri esseri umani — ancora e ancora, in un’infinità di piccoli modi, ogni giorno” (David Foster Wallace, This is Water).