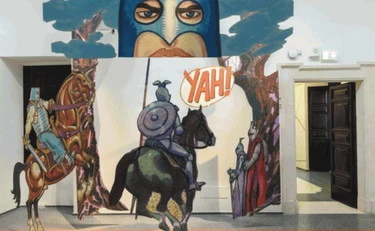È consuetudine ricordare giustamente Giovanni Boccaccio per il Decameron, opera magnifica con “dignità del libro da banco scolastico-universitario”, ma non l’unica prodotta da questo poliedrico innovatore della scrittura letteraria, impegnato anche come editore, filologo, biografo, geografo, agiografo, polemista, mitografo, teorico della letteratura, grafico e, a suo modo, filosofo. Con Boccaccio (Carocci, €27,00, pp. 287) Lucia Battaglia Ricci, fra le maggiori interpreti dell’opera del Certaldese, ci consegna una rinnovata edizione della biografia dello scrittore che, rispetto a quella del 2000, è qui arricchita di dati archivistici mai usati e dei più recenti affondi critici. Siamo di fronte a una larga rimeditazione dell’opera del toscano e al rapporto con Dante, di cui fu “allievo”, biografo, editore e commentatore delle prime diciassette cantiche dell’Inferno. Il trattatello in laude di Dante, tra verità e mito, può essere apprezzata come la prima vera biografia, raccogliendo testimonianze e notizie direttamente da chi l’aveva conosciuto.
Oltre al culto di Dante, “prima guida e primo lume” dei suoi studi, l’altra figura entrata nella vita di Boccaccio, è quella di Petrarca, di cui fu il più grande tra gli amici e discepoli. Divisi nel corpo ma non nell’animo, scriverà Petrarca. Oltre alle centoquattro biografie di celebri donne, Boccaccio orienta il suo talento agiografico verso una nuova stirpe di eroi: «Non più guerrieri o uomini d’azione o santi... ma letterati maestri di coscienze e correttori di costumi personali e sociali».
L’autrice evidenzia l’eclettismo di questo codificatore della novella, capace di essere sia perspicace interprete della realtà degli uomini, sia voce solenne di una concezione del vivere diffusa dalla letteratura cortese non più legata alla “corte” e al suo palcoscenico di virtù e bei costumi. La sua idea di “cortesia” segue una prospettiva più morale, sociale e politica, distante dall’unione di “cortesia e onestade” dantesca.
La vita di Boccaccio è un’autobiografia romanzata dalla quale emergono suoi “doppi”, tolti i quali, perde quota “la bella fiaba”, di essere figlio illegittimo di una figlia del re di Francia, sedotta e abbandonata dal padre mercante e uomo d’affari. Spinto dal padre studia controvoglia per diventare mercante, ma fin dalla nascita si sente, ab utero matris, destinato alla poesia. Gli anni del noviziato napoletano gli portano in dote un patrimonio di stili di vita dei più svariati paesi mediterranei, che gli tornerà utile nella “lunga fatica” compositiva del Decameron. Vasta è la sua cultura, assorbita grazie alla ricca biblioteca reale e alla frequentazione di letterati e ambienti fra i più esclusivi napoletani. È un autodidatta che legge i classici latini, che si tuffa nella grande poesia volgare e nei testi di filosofia morale come l’Ethica Nicomachea aristotelica. E se a Firenze le turbolenze economiche dividono gli uomini nelle guerre per conquistare l’egemonia regionale, a Napoli, Boccaccio può trascorrere la sua giovinezza tra privilegi e sotto un solo re, Roberto d’Angiò.
Casanova, ecco perché è diventato immortale
“Un Casanova”: non sono tanti gli esseri umani che sono riusciti a far diventare il proprio nome addirittura...In quegli anni la sua poesia non è solo scrittura lirica ma invenzione letteraria e ricerca di “pensieri eletti” e sublimi. Perché la poesia non esprime futilità ma vigore per “spremere i significati delle favole”, ed è per coloro che hanno ricevuto questo dono “dal seno di Dio”. Non è quindi nemica della teologia e della Scrittura sacra. Poesia di Dio, la chiama. La sua prima produzione letteraria nasce perciò dalla “dinamizzazione creativa” delle letture fatte, dalla riscrittura e ibridazione di testi altrui, assunti come modelli.
Di valore è la sua Lettera napoletana, uno dei primi esercizi di letteratura dialettale con accenti espressionistici, in cui, sdoppiandosi, Boccaccio entra in scena per fingere una lite con un ragazzo di strada. Figlie di questi anni sono pure la sperimentazione a tratti giocosa-burlesca delle Rime e il poemetto allegorico Caccia di Diana. Non trascurabile è il romanzo d’amore in prosa Filocolo, e il poema narrato “cantando”, Filostrato (“il vinto d’amore”) attraverso cui reinventa un episodio della guerra di Troia, privandola, però, delle implicazioni epiche, per favorire la fenomenologia amorosa tra Troiolo e Briseida, una sorta di “elegia imperfetta” che anticipa quella invece compiuta dell’Elegia di Madonna Fiammetta. Ma il testo che svetta su tutti è il poemetto pastorale Ninfale fiesolano che, ispirandosi alle Metamorfosi ovidiane e per “l’agile sintassi”, può essere stimata come l’opera più felice dopo il Decameron. In questa favola si racconta l’impetuosa passione del pastore Africo per l’irraggiungibile Mensola.
Dopo essersi vestito da ninfa per ingannare Mensola, Africo compie quell’atto ignominioso chiamato “stupro”. Trasparenza espressiva e crudo realismo raccontano la bestialità di questa violenza sessuale. Nel Decameron Boccaccio opera una mescolanza di vita e letteratura, sostituendo personaggi innominati e senza storia con protagonisti dotati di nome e cognome immersi nella realtà. L’esperienza napoletana fatta sui banchi dei mercanti, fusa con lo studio e l’eterogenea cultura assimilata, trova qui la maggiore sintesi e dà vita a un’esemplare prosa in lingua volgare.
E se per Orazio «vere devono sembrare le cose che si inventano per dilettare», per Boccaccio, al puro verosimile va opposto il vero delle “cose state”. Doveroso è ribadire l’accurata ed estesa attività editoriale di Boccaccio, copista instancabile dei libri che man mano entrano nella sua biblioteca, dove corregge le lacune testuali con “raffinata perizia filologica”. Trascrive testi di Apuleio, Terenzio, Marziale, Dante, e dell’amico Petrarca, al quale fa dono - ne era sprovvisto - di una copia della Commedia dantesca.
Nelle Familiari Petrarca si difende dalle accuse di disprezzare Dante, quando invece prova amore. Distanza c’è stata, scrive, ma la ragione stava nel timore di diventare un suo imitatore. Se Petrarca pare più concentrato sul cuore umano e Dante sull’universo, il focus di Boccaccio, con l’artificio della contaminazione e l’uso di più registri, è puntato sulla società e sul carattere degli uomini.