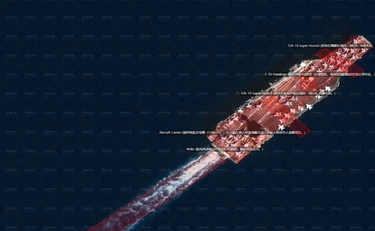L'Europa vive da 80 anni in una lunga fase di pace assicurata dalla presenza attiva degli Stati Uniti e dalla deterrenza nucleare. Questo equilibrio si è rotto quando la Russia ha letto il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan (disastroso nei modi e nei tempi, “La débacle di Biden”, titolo di copertina dell’Economist, 21 agosto 2021) come un segno di debolezza. I fatti sono squadernati, da quel momento la Cina si è fatta sempre più minacciosa nel quadrante del Pacifico e ai confini occidentali con Pakistan, Afghanistan e India; mentre la Russia ha preparato l’invasione dell’Ucraina ammassando truppe al confine fino all’ordine di Vladimir Putin del 14 febbraio del 2022. E l’Iran ha lanciato la sua grande offensiva contro Israele prima con Hamas e Hezbollah e poi - per la prima volta nella storia - con un attacco missilistico che ha provato l’efficacia dello scudo aereo di Israele e esposto al mondo la vulnerabilità dei cieli di Teheran.
Quella che segue è una breve indagine sulle due guerre, il loro intreccio, l’esito ancora aperto.
Ucraina. La guerra di logoramento di Putin.
L'Ucraina si è difesa con un vigore e un'efficacia che all’inizio del conflitto ha sorpreso Mosca, ma senza mai riuscire a respingere la Russia che, a sua volta, avendo fallito la campagna di movimento rapido della fanteria, ha optato per una sanguinosa guerra di logoramento. Un report pubblicato nel giugno scorso dal Centro di Studi Strategici di Washington racconta le difficoltà dell’esercito di Putin: «Le forze russe sono avanzate in media solo 50 metri al giorno in aree come Kharkiv, un ritmo più lento rispetto all’offensiva della Somme durante la Prima guerra mondiale, dove le forze francesi e britanniche avanzarono in media 80 metri al giorno. Il ritmo di avanzata russo è stato anche significativamente più lento rispetto a quello registrato durante offensive come quella della Galizia nel 1914 (1.580 metri al giorno), Gorizia nel 1916 (500 metri), Belleau Wood nel 1918 (410 metri), Leningrado nel 1943 (1.000 metri) e Kursk-Oboyan nel 1943 (3.220 metri). Anche il ritmo di avanzata della Russia in alcune parti dell’oblast di Donetsk, con una media di 135 metri al giorno, è stato notevolmente lento». Il numero di perdite sul campo è impressionante: «Complessivamente, in Ucraina sono morti fino a 250mila soldati russi, con oltre 950mila vittime russe totali, segno del palese disprezzo di Putin per i suoi soldati. Per contestualizzare questi numeri dal punto di vista storico, la Russia ha subìto circa cinque volte più vittime in Ucraina che in tutte le guerre russe e sovietiche messe insieme tra la fine della Seconda guerra mondiale e l’inizio dell’invasione su larga scala nel febbraio 2022. Inoltre, le vittime russe in Ucraina (in poco più di tre anni) sono 15 volte superiori a quelle della guerra decennale dell’Unione Sovietica in Afghanistan e 10 volte superiori a quelle dei 13 anni di guerra della Russia in Cecenia». Lo stesso report del Csis stima che «anche il tasso di mortalità ucraino è elevato, con un numero di soldati ucraini uccisi compreso tra 60mila e 100mila, per un totale di 400mila vittime (tra morti e feriti)». Putin in questa guerra ha un alleato più debole, l’Iran - costruttore dei droni che seminano morte in Ucraina e messo al tappeto da Israele e dagli Stati Uniti- ma conta sulla pazienza imperiale della Cina, per ora. Può continuare la guerra, ma il prezzo si sta facendo altissimo perfino per Mosca, che ha una tradizione storica nel mandare al massacro i propri soldati.
La guerra in Ucraina consuma materiali e risorse umane ad alta intensità. Il problema della durata, delle capacità logistiche, della rotazione delle truppe e della disponibilità di nuovi soldati da mandare al fronte dopo tre anni è diventato il tema numero uno dell’agenda degli strateghi militari e delle decisioni che devono prendere i politici, a Mosca, a Kiev, nelle capitali europee e a Washington. Che fare? C’è Donald Trump, potrebbe fare davvero il colpo da Nobel per la Pace, ma potrebbe anche fallire.
Il Medio Oriente da Gaza all’Iran
In Medio Oriente, la strage degli ebrei del 7 ottobre 2023 ha cambiato lo scenario di Gaza e innescato una formidabile azione militare multipla di Israele (in guerra sette fronti) che ha cambiato il quadro geopolitico, ma non lo ha ancora stabilizzato. A Gaza Hamas detiene ancora gli ostaggi ebrei, pubblicano video dei prigionieri in condizioni disumane, puntano al bagno di sangue e sperano di riconquistare il potere totale nella Striscia scommettendo sulla debolezza delle cancellerie europee (preoccupate più dei contraccolpi politici sul piano interno che del vero esito della guerra). Israele ha deciso di occupare tutta Gaza (e consegnarla poi alla gestione di Stati arabi alleati), mentre in Libano Hezbollah rifiuta il disarmo deciso dal governo e l’iraniano Ali Akbar Velayati, consigliere dell’ayatollah Ali Khamenei, invita alla disobbedienza i miliziani provocando una dura reazione di Beirut. Il lavoro non è finito, è solo all’inizio. Gli altri fronti restano tutti “attivi”: in Siria i tagliagole dell’Isis si sono messi la cravatta, ma restano una minaccia (vedere la strage dei Drusi, difesi solo da Israele, nel silenzio ignobile della comunità internazionale); gli Houthi nello Yemen sono indeboliti, ma capaci ancora di lanciare missili su Israele e sulle navi che attraversano il Mar Rosso; in Cisgiordania l’esercito israeliano è costretto a intervenire per fermare i terroristi. La mossa del governo Netanyahu ha ribaltato decenni di piani militari con obiettivi politici limitati (ricordo per esempio l’operazione “Piombo Fuso”, 27 dicembre 2008-18 gennaio 2009) e colto Hamas in contropiede.
Si parla di un ritorno ai negoziati: il Qatar, l’Egitto e gli Stati Uniti lavorano a una bozza che prevede il rilascio degli ostaggi, il disarmo di Hamas e delle altre milizie palestinesi, l’esilio dei leader militari, in cambio della fiine dei combattimenti e di un ritiro completo da parte di Israele, con un nuovo organismo creato per gestire la Striscia di Gaza. Sono ipotesi sempre sul campo, la decisione del governo Netanyahu è anche uno strumento di pressione.
D’altronde, come spiegava ieri una fonte israeliana citata dal Times Of Israel «con l’inondazione della Striscia di Gaza di aiuti umanitari, la campagna di fame di Hamas sta svanendo. Hamas sa di essersi data la zappa sui piedi con i video degli ostaggi affamati, e quindi la possibilità che tornino ai negoziati non può essere esclusa». La guerra resta aperta, la pace è lontana, Israele sta pianificando la prossima fase della campagna militare.
Il sottosopra di Trump
La guerra in Ucraina va avanti da 1.264 giorni, quella in Medio Oriente è in corso da 674 giorni. Il grande buco nero di questa storia si chiama Europa, un’entità senza identità, capace di sfornare documenti dalle nobili intenzioni, mettere in campo aiuti (organizzati dai singoli Paesi), ma non di risolvere le crisi. La dichiarazione di ieri di Italia, Germania, Gran Bretagna, Francia, Canada, Austria, Norvegia, Nuova Zelanda e Australia (con la firma dei francesi che è arrivata in ritardo, quando il comunicato era già stato diffuso, un altro segnale di gran confusione di Emmanuel Macron, indispettito dal ruolo dell’Italia e dalla prospettiva poi sfumata - Mosca si è opposta - di un vertice tra Trump e Putin a Roma) resta un dejà-vu. Niente di nuovo sul fronte Occidentale, mentre la palla è giocata dagli Stati Uniti, capaci sì di grandi complicazioni, ma anche di sortite a sorpresa che cambiano la storia.
L’arrivo di Trump ha dato una scossa al copione di Washington nelle due guerre, la Casa Bianca- con alterne fortune, ma sempre tenendo l’iniziativa e la pressione sugli attori in campo - è entrata in scena con una serie proposte per chiudere i conflitti, plasmando un nuovo ordine che si basa sulle rotte dell’energia, la trasformazione tecnologica e il commercio globale. Piaccia o meno, Trump è un game changer, è capace di sparigliare le carte, è improvviso, irruento, umorale, è un sottosopra dotato di una qualità che i suoi nemici ideologici hanno sempre sottovalutato: è efficace. L’hanno preso sottogamba, fino a quando non ha presentato il conto della sua politica dei dazi e con un colpo d’ala ha bombardato i siti nucleari dell’Iran, appoggiato il piano del governo israeliano su Gaza e fissato un vertice sull’Ucraina con Vladimir Putin in Alaska il 15 agosto. Trump è alla Casa Bianca da sei mesi, è da 200 giorni al potere e il mondo è cambiato.
I suoi detrattori dicono «in peggio», ma è fuori discussione che le guerre non siano iniziate sotto la sua presidenza, che la strategia di Joe Biden sia stata un fiasco militare e politico (armare l’Ucraina per non perdere, ma non a sufficienza per respingere i russi), che in Medio Oriente i democratici abbiano sostenuto Israele senza crederci, al punto da dare all’Iran l’impressione di poter muovere guerra indisturbato con il braccio armato di Hamas e Hezbollah. Trump ha rotto questo schema del passato, Benjamin Netanyahu ha ribaltato lo scenario che lo vedeva sconfitto, mentre l’Europa in Ucraina resta appesa alle decisioni del Pentagono (da cui dipende la guerra di Kiev) e in Medio Oriente insegue uno schema (due popoli due Stati) che la storia ha dissolto quando Hamas ha sgozzato i figli di Israele. Non è la fine, siamo al principio di un nuovo inizio.