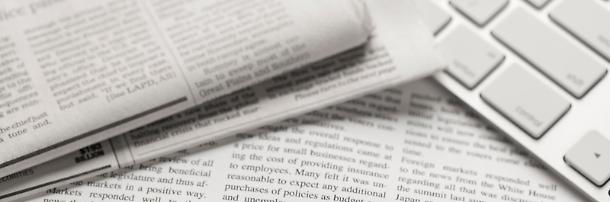Pubblichiamo stralci del discorso del nostro direttore editoriale Daniele Capezzone, invitato ieri a parlare di fronte alla Commissione Anti-discriminazioni del Senato insieme al direttore del Tempo Tommaso Cerno, entrambi vittime di episodi d’odio legati all’espressione delle loro idee.
Com’è noto, l’occasione è stata spiacevolmente creata da una pioggerellina di minacce subìte. Circostanze che naturalmente non ci impressionano, ma sono agli atti. Minacce contro il direttore del Tempo Tommaso Cerno. Minacce contro il nostro editore e dirigenti del nostro gruppo. Minacce contro Libero e il Giornale, con manifestazioni sotto la sede di Milano di questi due giornali, che ora è oggetto di un presidio permanente delle forze dell’ordine. Manifestazioni durante le quali sono stati esposti di fatto come bersagli immagini dei volti dei colleghi Mario Sechi e Alessandro Sallusti, oltre al mio.
Per ciò che mi riguarda personalmente, al di là di tutto ciò di cui sono oggetto da tempo per le mie note posizioni a difesa di Israele, l’episodio più significativo risale all’arco temporale novembre ‘23 - settembre ‘24.
«Userò tutta la tua famiglia per fartelo capire»: questo messaggio, con una serie di elementi assai circostanziati, era direttamente indirizzato a me. Ma ce n’erano anche molti altri - come dire - più generali, rivolti erga omnes verso tutti noi occidentali, per definizione infedeli: «Preparate le vostre teste ad essere tagliate», «Io amo la vendetta», e ancora «Morire non è un problema», «Esploderò», «Percorrerò questa strada fino alla morte». Parole di El Mahdi Tbitbi, il 28enne marocchino che ho personalmente provveduto a denunciare. In collegamento con il Tg4 dalla sede di Libero, una sera di novembre ‘23 avevo commentato un servizio sul velo islamico, sottolineando come in molti casi si tratti di un’imposizione ai danni delle donne e non di una scelta libera. Cosa che è parsa al marocchino una valida ragione per minacciarmi.
MATRICE ISLAMISTA
Dopo un’approfondita indagine - per la quale ringrazio molto la Digos e gli inquirenti - questo signore è stato arrestato nel settembre del ‘24 a Milano. E sono emersi numerosi elementi di enorme interesse. Il tipo era in Italia dal 2011, e per un certo numero di anni appariva ben integrato: atteggiamento poi mutato e addirittura rovesciato a partire dal 2022. Il che - prima osservazione significativa - mostra come i processi di radicalizzazione possano tranquillamente avvenire qui, in territorio italiano, anche molti anni dopo l’arrivo. Altro aspetto interessante e inquietante: il marocchino, a fasi alterne, manifestava intenzioni violente qui (verso di me ma anche verso importanti figure politiche, inclusa la premier Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini), e contemporaneamente si dichiarava un “mujaheddin” pronto ad andare a combattere in Palestina. Segno che per questi fanatici il Medio Oriente e le nostre capitali occidentali sono semplicemente due diversi teatri della stessa battaglia Ma ora, lasciando da parte questi casi concreti, vengo al tema più generale della nostra audizione, la libertà di parola e il discorso d’odio. Non vi nascondo di essere lacerato tra due sentimenti opposti. Da un lato, sono un fiero sostenitore del free speech, della libertà di pensiero e di espressione come beni nella mia scala di valori- pari a quello della stessa vita. E dunque, per antica convinzione liberale, credo che lo stato e la legge non debbano permettersi di limitare quella libertà, che non deriva da loro ma che pre-esiste rispetto all’apparato pubblico.
Dall’altro lato, però, constato una strana intermittenza nell’applicazione del criterio della obbligatorietà dell’azione penale. Mi spiego. Esistono norme nel diritto italiano che - per le ragioni ampiamente citate - non sono le mie preferite, e mi riferisco ad esempio alla Legge Mancino: norme che puniscono frasi, azioni, slogan, perfino gesti, volti a incitare all’odio, alla violenza, alla discriminazione su basi razziali, religiose o etniche. Ecco, mi chiedo: come mai, dinanzi alle plateali violazioni di quelle norme (in primo luogo contro gli ebrei e le comunità ebraiche, e spesso ma non solo da parte di rappresentanti dell’estremismo islamista) è così rara l’applicazione di quelle norme? Può sorgere il dubbio che, anche in un passato recente, ci fosse più sensibilità in alcuni (anche in sede culturale e giudiziaria) quando si dava per scontato che la bestia antisemita potesse in futuro ripresentarsi solo e nuovamente “da destra”, e che magari sicuramente in buona fede, non voglio ipotizzare diversamente- ci sia minore sensibilità se quella stessa bestia si ripresenta altrove, in altra area politica o soprattutto da parte dell’estremismo islamista. Ma questo- lo comprendete bene - crea un problema di fondo. Che facciamo? Dosiamo l’intervento in questa materia, la severità o il suo contrario, in base a valutazioni discrezionali? O ci muoviamo non in base all’analisi oggettiva dei comportamenti ma all’analisi soggettiva di chine sia l’autore?
DIFESA DEL FREE SPEECH
Su queste basi, vi propongo tre caveat, cioè alcuni punti rispetto ai quali secondo me sarebbe prudente privilegiare il pedale del freno, e invece tre possibili azioni in positivo - spero - di limpida impronta liberale. Ma prima, come promesso, i caveat. Prendo come doveroso punto di riferimento il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva “su natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d’odio” che rappresentò, nella scorsa legislatura, il cuore del lavoro della vostra Commissione. Leggo e cito: «Si è certamente sempre liberi di odiare» ma «il sentimento d’odio va distinto dai discorsi d’odio».
Quando scatta un “discorso d’odio”? Secondo il documento di questa Commissione, occorrono tre elementi: «la manifesta volontà di incitare all’odio», «un incitamento che sia idoneo a causare atti di odio e violenza», e «il rischio che tali atti si verifichino». Comprendo e apprezzo le eccellenti intenzioni, e a quelle aderisco toto corde. Ma con rispetto profondo - mi permetto di chiedere: che vuol dire “idoneo”? In prospettiva, affidiamo a un magistrato, a un funzionario pubblico, la definizione del confine tra cosa sia “idoneo” e cosa non lo sia?
Confesso una seconda perplessità: ve la presento con una sincerità che spero apprezzerete. Quel testo fa riferimento a uno schema consolidato, e cioè all’elencazione di gruppi ritenuti vulnerabili, definiti «categorie e minoranze target». E qui scatta la mia perplessità liberale: si è forse protetti solo perché si è parte di un elenco? E invece non si è protetti se non si è inclusi? Va sottolineato che in Italia (ed è un retaggio di per sé discutibile nella mia ottica liberale) esiste già la figura dei reati di opinione. Ma evidentemente c’è chi vuole ancora di più, nella convinzione che le disposizioni penali esistenti non coprano - ad esempio - orientamento sessuale, genere e disabilità. Va peraltro ricordato che esiste un’aggravante (quella dei “motivi abietti”) che può essere sempre utilizzata: ma anche qui ad alcuni non basta.
MASSIMA ATTENZIONE
Ecco dunque (torno ai caveat che avevo preannunciato) tre gravi ragioni che sconsigliano vivamente- a mio avviso - di proseguire su strade di questo tipo, pur partendo dalle migliori intenzioni.
Primo. C’è la comprensibile ma insidiosa ossessione normativa, l’idea che tutto si risolva con delle norme in più. Secondo. Incidere sul free speech è un esercizio rischiosissimo: non a caso, negli Usa, il Primo Emendamento considera sacra la libertà di espressione (per quanto, come si sa, anche lì quel caposaldo sia sempre più sotto attacco). Qui invece si sottovaluta un punto di fondo: quando si comincia a sindacare la libertà di parola, si sa da dove si stia iniziando ma non dove si possa andare a finire. Chi decide il confine? Affidiamo al giudice il sindacato ultimo sulla libertà di espressione?
Terzo. C’è un rischio riassunto dal verbo inglese weaponize, cioè fare di qualcosa un’arma politica. Qui il rischio è che questa cassetta degli attrezzi sia usata contro soggetti o forze - per così dire - “sgradite”, con una carica inevitabile di discrezionalità e arbitrarietà.
TRE PROPOSTE
E allora, dopo aver svolto una rispettosa ma sincera pars destruens, ho il dovere intellettuale di proporvi con umiltà una possibile pars construens, con le tre proposte che vi ho preannunciato. Proposte che nascono a partire da un criterio, da un ragionamento, che spero non sia bollato come “islamofobo”. Non possiamo non vedere come, con particolare riferimento alle spinte e agli atti di antisemitismo, essi derivino nella stragrande maggioranza dei casi proprio dall’estremismo islamista. Vengo dunque alle tre proposte, ispirate a criteri rigorosamente liberali. La prima riguarda l’associazionismo e la vita culturale e religiosa delle comunità islamiche. Occorre un censimento (uso appositamente un concetto sdoganatissimo, che evoca solo positive esigenze di trasparenza) di tutti i luoghi di culto, di incontro e di associazionismo ispirati all’Islam sul nostro territorio. La medesima trasparenza va richiesta sulle relative fonti di finanziamento. La seconda proposta riguarda invece il settore pubblico, e più precisamente il nostro sistema scolastico e universitario. Il primo passo - rigorosissimo quanto di limpida impronta liberale - sarebbe quello di ritirare i finanziamenti pubblici a qualunque luogo o istituzione pubblica dove siano avvenute forme di censura, dove sia stato praticato il no platforming o il de-platforming, dove cioè siano stati impediti dibattiti, cacciati oratori, allontanati i sostenitori di tesi “sgradite” a violenti e prepotenti. La terza e ultima proposta è infine un contributo di metodo rispetto al dibattito pubblico da aiutare e favorire, con particolare riferimento alla radiotelevisione pubblica.
Fatevi promotori presso la Rai, se lo ritenete, di un format semplice e classico. Si tratterebbe di uno schema aggiuntivo, non sostitutivo di alcunché. Sia su un fatto del giorno, sia su tema teorico o culturale, sia su una questione di politica interna o di politica estera, si tratterebbe di immaginare dibattiti “uno contro uno”, con parità di tempi, con repliche e risposte senza reciproche interruzioni, con saluto iniziale e finale tra i contendenti. A tutti si richiede non di rinunciare alle proprie idee (anzi), ma di argomentarle e sostenerle razionalmente. Una grande scuola di dialettica sempre aperta, di allenamento costante a offrire il meglio e non il peggio di sé. Risolverebbe tutti i problemi? Certo che no. Ma sarebbe una polizza di assicurazione- preziosa e non costosa - sulla vita della nostra democrazia.