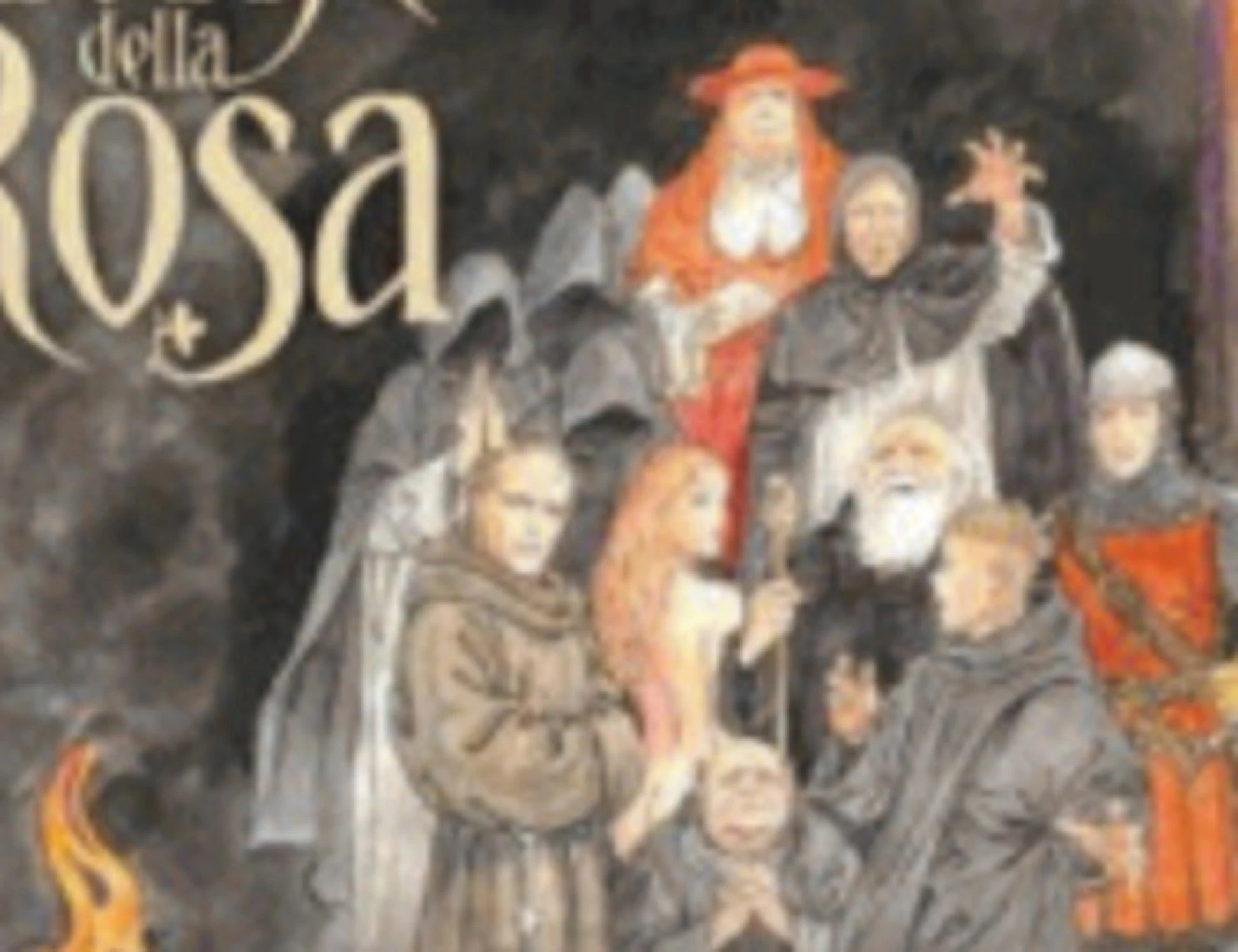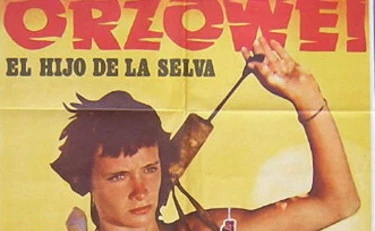La notte nell’abbazia è un animale in agguato. Respira dietro ogni arco, scruta dalle feritoie, si annida negli umidi sotterranei, lì dove i libri sussurrano segreti pericolosi. Nel cuore di questa notte buia, Milo Manara ambienta il secondo e conclusivo volume della sua versione de Il nome della rosa, trasformando il capolavoro di Umberto Eco in un viaggio sensuale e inquieto, una rappresentazione grafica che mescola beltà e peccato, censura e conoscenza senza soluzione di continuità. Le tavole del maestro 80enne non si limitano a illustrare, costruiscono un mondo e lo rendono corporeo, restituendo al romanzo una potenza visiva che ne amplifica il respiro fra incanto e pericolo. L’operazione, sostenuta dagli eredi di Eco e da Elisabetta Sgarbi e pubblicata da Oblomov Edizioni (pp. 72, € 22 in libreria dal 28 novembre), è un adattamento capace di restituire la forza secolare dell’abbazia, l’imponenza della Sacra di San Michele che aveva ispirato lo scrittore, restituendo la precisione del bestseller da oltre sessanta milioni di copie vendute nel mondo. Già nel primo volume, pubblicato due anni or sono, Manara aveva sorpreso per fedeltà e originalità, modellando Guglielmo da Baskerville sulle fattezze di Marlon Brando, accompagnando la crescita emotiva di Adso da Melk e chiudendo il primo tomo con una delle scene più iconiche del romanzo: l’incontro carnale fra il novizio e la fanciulla del villaggio che, a sua volta, ha le sembianze di Miele, la creatura femminile che torna nelle maggiori opere di Manara.
L’INQUISIZIONE
Questa sequenza apre il secondo volume, esplodendo in tutta la sua ampiezza sensoriale: il calore del forno, i corpi nudi che emergono dalla penombra, il tremore del ragazzo dinanzi alla nudità della giovane e quello stupore che Eco intrecciava sapientemente ai versi immortali del Cantico dei cantici. Manara illumina la scena, facendone una rivelazione, un passaggio iniziatico che spalanca l’ingresso del novizio Adso nel mondo adulto: non più santo e casto ma peccatore e uomo. Subito dopo, l’abbazia mostra la sua vera natura: la donna viene catturata, torturata e condotta al rogo. Non si tratta di un luogo di meditazione e preghiera ma di una macchina del potere costituito. La narrazione entra subito nel vivo e Manara rende tangibile la violenza dell’Inquisizione, lo scenario mediante il quale Bernardo Gui esercita il proprio dominio. Il processo che si consuma tra i pilastri e le navate ha una forza quasi cinematografica: volti tesi, posture rigide, gesti spezzati. L’inquisizione diventa un teatro della censura, perseguitando la diversità, seminando il sospetto e soffocando il dissenso.
LA CENSURA
Al centro di tutto rimane la biblioteca, il dedalo proibito che custodisce migliaia di volumi sepolti dietro pareti e specchi deformanti. Manara la disegna come un organismo vivente, un ventre oscuro in cui il sapere non rischiara l’animo, ma brucia la carne di chi osa avvicinarsi. Il libro avvelenato – lo strumento con cui il monaco Jorge da Burgos, il vero antagonista di Guglielmo, elargisce la somma punizione – è la metafora più crudele della censura: il pensiero libero diventa mortale, il riso aristotelico viene condannato come eresia. Le dita nere, le bocche deformate, le pagine che diventano scottanti. E, infine, il fuoco. La distruzione della biblioteca, è resa con una potenza che appartiene ai grandi cicli pittorici: fiamme che divorano scaffali, travi che cedono, corridoi che collassano, codici che si accartocciano come foglie invernali. È un’apocalisse laica, una falsa purificazione che uccide ciò che non può essere controllato. Il rosso si mescola al nero della notte, il fumo alla neve, la tragedia alla bellezza: il sapere che brucia diventa un urlo, una preghiera senza risposta.
Addio bei tenebrosi, ecco i detective improbabili
C'erano una volta Auguste Dupin e Sherlock Holmes. E poi, il capitano Bellodi di Sciascia, i poliziotti di Ed McBain...Nelle ultime pagine, quando Adso ormai adulto ritorna sulle rovine dell’abbazia, Manara chiude il cerchio con una fedeltà totale al romanzo: la figura del monaco avvolta nel silenzio delle pietre, il paesaggio invernale, la memoria che si fa eco. E infine, ecco il verso che Eco aveva scelto come commiato, riportato per intero anche da Manara: “Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus”. L’artista lo accoglie, lasciandolo risuonare su fondo bianco, eco lontana di tutto ciò che è andato perduto. Con questo secondo volume, Manara firma una delle sue opere più attese, un lavoro che amplifica la pagina scritta - di per sé insuperabile - aprendo anche a nuovi potenziali lettori, con la forza luminosa e terribile delle visioni destinate a perdurare nel tempo.