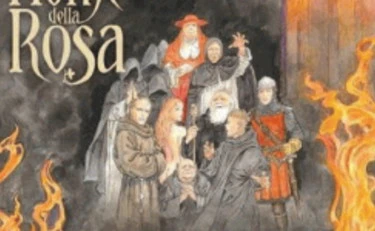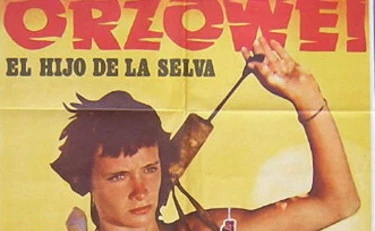Il vino dall’Antica Roma a oggi. Un testimone di gusto, cultura e potere. Accorgimento geniale grazie al quale gli antichi romani hanno addirittura tenuto insieme e protetto l’Impero, secondo Henos Palmisano, medico, specialista in patologia clinica ed ematologia con una passione che unisce bon vivre e Storia. «Sono convinto che una giusta posologia del vino faccia bene all’individuo. Il classico bicchiere a pranzo e cena, mai a digiuno, fa bene alla digestione. Come pure è inconfutabile che il vino produca endorfine, quindi fa bene all’umore!» Un approccio alla vita e al pensiero, questo, che spesso trova il punto di contatto in un calice di vino. O verrebbe da dire meglio in un brindisi, come il nome della città salentina sotto le cui colonne trova approdo la via Appia, regina viarum e da dove, proprio al tintinnar di bicchieri, già dall’epoca romana, si augurava buon viaggio alle navi che dal porto della città, molto devota al dio Bacco, salpavano verso oriente dove la coltivazione della vite ha avuto origine. Ne abbiamo parlato con il dottor Palmisano a margine del convegno celebrativo, da lui stesso tenuto, ai Castelli Romani, precisamente nella storica cantina Castel de Paolis della famiglia Santarelli che proprio quest’anno per celebrare i primi quarant’anni di produzione ha voluto aprire la tenuta a incontri di assoluto rilievo. Se, infatti col dottor Henos si è tornati a due mila anni fa, questa mattina, con l’evento conclusivo, si rifletterà con il luminare della viticoltura, professor Attilio Scienza e, tra gli altri, l’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giampiero Righini su «I nuovi contenuti della vocazione viticola».
Il dottor Palmisano, figlio e fratello di un enologo, quindi beneficiato anche da un “vizio di famiglia”, nella sua prolusione a sfondo storico ha sottolineato come, sebbene la cultura del vino sia nata in oriente, in Grecia, i veri diffusori nel mondo sono stati i romani. «I Romani furono molto aiutati dai Greci, che portarono i migliori vitigni dall’Oriente in Italia che chiamavano non a caso Enotria. Basti pensare a vini come l’Aglianico, il cui nome deriva chiaramente da ellenico e il Greco, vitigno bianco, sulle cui origini non possono certo esserci dubbi. Il merito di tale successo va a quelli che nel tempo si sono distinti come veri e propri colonizzatori a suon di uva». A partire dall’epoca di Giulio Cesare che era uso «fornire vino ai legionari, inizialmente trasportato in anfore, poi in botti, dopo la conquista della Gallia». Lo stratagemma grazie al quale, secondo Palmisano, i romani tennero unito l’impero, non sta però tanto nell’utilizzo che ne facevano i soldati, quanto nel fatto che nei luoghi più lontani era uso piantare vite, «segnando così i confini dell'Impero Romano (il Limes, costituito dal Danubio e dal Reno) ovvero laddove finiva l’impero romano». Una strategia consolidata al punto che l’imperatore Marco Aurelio Probo, nel III secolo dopo Cristo «aveva capito che se dava come premio di fine carriera ai legionari un terreno sul limite dei possedimenti imperiali, quelli l’avrebbero difeso strenuamente, avvisando sulle invasioni barbariche».
A propiziare una visione così benevola nei riguardi del vino c’è certamente anche il fatto che, da sempre, il prodotto della vite sia considerato il “nettare degli dei”. Tanto che nell’Antica Roma le divinità più rappresentate furono Bacco e Venere, nel cui nome latino Venus sarebbero antiche connessioni etimologiche con la parola vinum, accomunate dalla radice sanscrita vena che stava ad indicare proprio l’amore passionale. Dispute che si perdono nella notte dei tempi. Fatto sta che per la lettura, decisamente più maschilista, che ne fece anche Cicerone che, rifacendosi al mos maiorum, il vino fu a lungo associato al vir cioè all’uomo, per cui restò duramente e per molti secoli vietato alle donne. Sempre secondo leggende divine, a portare il vino a Roma sarebbe stato in realtà il dio Saturno che, scacciato da Giove, si applicò sul Campidoglio a istruire sulla coltivazione della vite. Mentre a un meno conosciuto Bacco dalla saggezza anche medica è associato il mito che vede Dioniso strappare una vite dall’oriente e piantarla in un cervello di uccellino, poi in un teschio di leone e infine di asino. Una metafora atta a simboleggiare i diversi effetti del vino a seconda della quantità: allegria (uccellino), forza (leone) e stupidità (asino). Un invito alla moderazione che spiega come l’età classica, dopo duemila anni, sia ancora fucina di storie e valori utili anche alla vita di oggi.