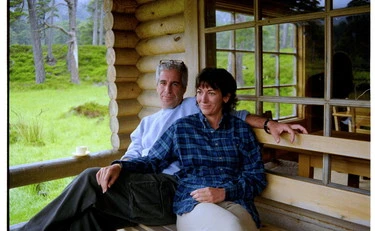È passato quasi un anno dal discorso della seconda vittoria di Donald Trump: a Mar-a-Lago, il 6 novembre 2024, il 45esimo presidente degli Stati Uniti appena diventato anche il 47esimo disse ai suoi sostenitori che Dio gli aveva risparmiato la vita per un motivo, che era quello di mettere l’America al primo posto e di farla «più grande, più coraggiosa, più ricca, più sicura e più forte» di quanto non fosse mai stata prima. Un incubo per i dem di mezzo mondo, che già s’immaginavano americani e russi a braccetto a premere lo scarpone sulla testa dell’Ucraina e Israele a briglia sciolta in Medio Oriente. Tutt’altro che isolazionista, però, Trump ha scontentato i primi e qualcuno pure dei secondi, ha preso il logoro ordine internazionale liberale e, a raffiche di dazi minacciati, messi, tolti, alzati, dimezzati, raddoppiati ancora e eliminati di nuovo, ha capito che “la pace attraverso la forza” avrebbe portato più risultati rispetto “al caos attraverso la de-escalation”. Ai fronti di scontro già aperti ne ha aggiunti ora due, il Venezuela prima e la Nigeria poi. In Sudamerica, Washington ha cominciato a colpire le imbarcazioni dei narcotrafficanti a inizio settembre.
Il Mar dei Caraibi si è fatto via via più affollato: lo schieramento aeronavale ha raggiunto i livelli della Guerra del Golfo e si sta arricchendo anche della portaerei Ford, la più letale della Marina americana. Bombardieri sono stati mandati in ricognizione vicino alle coste venezuelane e la Cia è stata autorizzata dalla Casa Bianca a compiere azioni sotto copertura nel Paese. I marines hanno condotto esercitazioni di sbarco a Porto Rico e proprio lì, segnalano i satelliti, è stata riaperta la base navale Roosevelt Roads, chiusa nel 2004. Finora l’operazione Usa ha provocato la morte di 65 narcos ha distrutto 15 imbarcazioni e un semisommergibile. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha alzato il telefono più volte: ha chiamato Russia, Cina e Iran per chiedere assistenza militare, forniture radar e componenti di ricambio per gli aerei soprattutto. Ma l’asse dello sconvolgimento sa che è meglio guardare e non toccare. Secondo fonti del quotidiano brasiliano O Globo, infatti, Maduro si sarebbe già detto disposto a risolvere la questione della lotta al narcotraffico, a condizione di ottenere garanzie di partecipazione chavista ad un possibile governo di transizione e di amnistia per i membri dell’attuale esecutivo.
«Armi multimilionarie stanno facendo esplodere gommoni», è stato il commento di un ex funzionario del Pentagono: al di là della lotta alla droga, Trump vuole liberarsi di un nemico e dei suoi alleati fuori dalla porta di casa. Sulla sponda opposta dell’Atlantico, in Nigeria, gli Stati Uniti si stanno preparando all’azione se il Paese non proteggerà i cristiani dagli attacchi dei jihadisti: l’ha annunciato il presidente e gli ha fatto eco il segretario alla Guerra Pete Hegseth. Dopo oltre vent’anni di Boko Haram, 40mila morti e 2 milioni di sfollati, il presidente nigeriano Bola Tinubu ha già risposto che venerdì incontrerà Trump e che accoglierà con favore l’aiuto degli Stati Uniti nella lotta contro «gli insorti islamisti, a condizione che venga rispettata la sua integrità territoriale». Anche al presidente del Paese più popoloso dell’Africa, con 230 milioni di abitanti, diviso tra un nord a maggioranza musulmana e un sud in gran parte cristiano, il cui sottosuolo di litio, cobalto e nichel è già finito nelle grinfie di Pechino, conviene cominciare a girare la testa di 180 gradi.