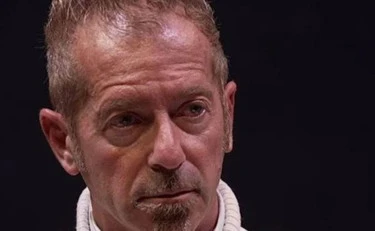Il caso Venezi alla Fenice ha rivelato, più di ogni inchiesta ministeriale, lo stato confusionale in cui versa il dibattito culturale italiano. Sui social si leggono anatemi, insulti, editoriali improvvisati da gente che, a giudicare dai toni, confonde un direttore d’orchestra con un capotreno. C’è chi invoca “il voto degli orchestrali”, chi parla di “democrazia artistica”, chi si proclama esperto di statuti dopo aver letto tre post su Facebook. Benvenuti al Festival dell’Ignoranza Lirico-Sinfonica, dove la competenza è l’ospite d’onore... che nessuno ha invitato. Intanto il Teatro non è un condominio. Per chi ancora crede che l’orchestra possa votare il suo direttore musicale: no, non funziona così. Le Fondazioni lirico-sinfoniche italiane sono strutture con uno Statuto preciso e gerarchie chiarissime: è il Consiglio di Amministrazione che nomina il Sovrintendente, il quale a sua volta sceglie il Direttore Musicale. Fine.
Nessun referendum, nessun ballottaggio, nessun televoto. Gli orchestrali possono certo esprimere un parere, magari davanti a un caffè, ma non hanno alcun potere di nomina né di revoca. E confondere la prassi (cioè la cortesia di consultarsi) con la legge è come scambiare un bis per un contratto discografico: non funziona così da nessuna parte, nemmeno a Bayreuth.
Tra doveri e privilegi (che esistono, eccome). Gli orchestrali italiani sono professionisti di altissimo livello, ma anche lavoratori tutelati come pochi altri nel mondo dello spettacolo. Sono dipendenti a tempo indeterminato, con tredicesima, quattordicesima, ferie pagate, permessi, tutele sanitarie e contributive, sindacati, fondi integrativi, e un monte ore annuale rigidamente definito tra prove e recite.
Gli stipendi? Tra 2.500 e 3.500 euro netti al mese nei grandi teatri, fino a 4.000 per le prime parti. Nel resto d’Europa non se la passano meglio: in Germania, stessi importi (ma con tasse più alte); in Inghilterra, molti sono freelance senza ferie né tredicesima; in America, chi non è nella top orchestra finisce presto al call center. Altro che proletariato musicale: gli orchestrali italiani sono tra i più protetti e pagati del settore culturale europeo. E fanno bene a esserlo — ma almeno lo si dica chiaramente, invece di evocare scenari di sfruttamento ottocentesco.
La controparte dei privilegi è la disciplina: prove obbligatorie, puntualità, disponibilità a seguire le indicazioni del direttore. Le assenze ingiustificate si sanzionano, lo sciopero va comunicato, e il teatro non è il Far West dove ognuno decide chi deve salire sul podio. Il direttore dirige, e l’orchestra suona: non è un concetto reazionario, è la base stessa dell’arte musicale organizzata. La protesta e l’alibi politico. I professori della Fenice sostengono di non essere stati “coinvolti”. Peccato che il sindaco di Venezia li abbia invitati al dialogo fin dal primo giorno, e loro abbiano rifiutato perfino di incontrare la nuova direttrice.
Dunque non si è trattato di mancanza di confronto, ma di rifiuto del confronto. E quando un’orchestra che non ha mai suonato con un direttore ne proclama l’inadeguatezza, non serve un musicologo per capire che l’obiezione non è artistica ma politica. In tutta questa baraonda, la morale è una sola: in Italia la musica è ancora terreno di scontro ideologico, e ogni podio diventa un seggio elettorale. Le orchestre meritano rispetto, ma anche chiarezza: non sono assemblee parlamentari. Beatrice Venezi non è la prima né sarà l’ultima a finire nel tritacarne ideologico di un Paese che, invece di ascoltare, preferisce schierarsi. Perché in Italia basta impugnare una bacchetta perché qualcuno gridi al complotto, al favoritismo, al sacrilegio. Se un giorno l’Italia imparerà a distinguere la musica non dal rumore di fondo, ma dal chiasso del corporativismo, dello scontro politico e delle appartenenze, forse allora — finalmente — torneremo a sentire ciò che conta davvero: il suono limpido del merito.