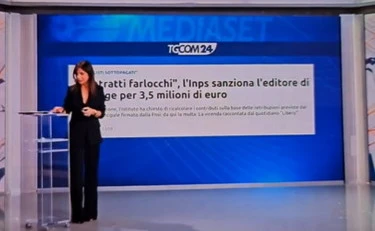Gli uomini non sono immortali, fortunati coloro che riescono a invecchiare, tra i quali ci sono anche io e c’era anche il Cavaliere. A cui devo molto, tra l’altro mi ha trasferito tra i benestanti pagandomi alla grande. Eravamo amici, ci davamo del tu. Poco prima di ammalarsi mi telefonò. Scherzosamente mi chiamava Numero uno, io che forse non riesco ad essere il centesimo. Noi due parlavamo raramente di politica, una volta per ridere gli dissi che non ero io a pensarla come lui, ma era lui a pensarla come me. Le mie battute scanzonate lo divertivano. Ieri mattina, diffusasi la notizia del suo decesso, sono stato interrogato sul mio stato d’animo da diversi media.
Riassumo le mie dichiarazioni. Ora che se ne è andato finalmente pure i cretini riconosceranno che Silvio è stato un grande, era grande sin da piccolo. Si è laureato da giovanissimo, e presto è diventato il primo costruttore nazionale, erigendo Milano 2, la città satellite più bella d’Europa. Poi ha lanciato tre emittenti televisive più importanti d’Italia, pareggiando il conto degli ascolti con la Rai. Non pago, ha fondato con Doris Mediolanum, una banca di livello continentale. Non è finita. È diventato padrone del calcio con il suo Milan che ha trionfato più di qualsiasi altra squadra. E veniamo alla politica. Silvio in tre mesi tra il 1993 e il 1994 ha fondato un partito col quale ha vinto immediatamente le elezioni. Un fenomeno come lui non esisteva in natura. Il resto è noto. Nonostante egli fosse una persona speciale mezzo Paese gli ha fatto la guerra senza requie, i comunisti e similari hanno fatto di tutto, invano, per demolirlo. Solo la magistratura con una sentenza balorda è riuscito a metterlo, per poco, in ginocchio.
Ma tutte queste cose sono arcinote, non voglio raccontarle ancora. Piuttosto vorrei rammentare il suo inizio come uomo che sarebbe diventato di Stato. Tutto cominciò con la sua lite con Indro Montanelli, il direttore del Giornale di proprietà di Silvio. Il resto lo conoscete. Aggiungo soltanto che spesso solo la morte rende giustizia agli individui importanti. Nell’aprile del ’93 ricevetti la chiamata di Silvio Berlusconi. Ancora non si parlava del lancio in politica e Forza Italia non esisteva. Dirigeva allora l’ufficio stampa dell’imprenditore un giornalista con cui avevo lavorato a Il Corriere, Giovanni Belingardi, amico mio carissimo. Fu lui a contattarmi informandomi che Berlusconi desiderava incontrarmi. Non avevo motivo di rifiutare l’invito. Giovanni venne a prendermi in ufficio per portarmi ad Arcore. Mi lasciò davanti al cancello e andò via.
Feltri, quando in carcere si torna a vivere: le storie di cinque detenuti a Quarto grado
Troppo spesso, purtroppo, ci dimentichiamo che lo scopo della detenzione non è punitivo, bensì, come stabi...IL PRIMO INCONTRO
«Il signore in questo momento si trova in giardino, sta accompagnando Gianni Agnelli all’elicottero. Se si incammina per questo vialetto, vi incrocerete», mi comunicò il maggiordomo appena varcata la soglia della residenza. E fu proprio lì che ci vedemmo per la prima volta, su quel vialetto. L’imprenditore mi venne incontro e mi salutò in modo cordiale, quasi affettuoso. Era giovane, gentilissimo ed energico. Avevo davanti a me un uomo semplice. Non provavo soggezione. Non ho avuto alcuna palpitazione. Mi interessava capire soltanto cosa egli volesse dame. Durante il pranzo piovvero le proposte. Berlusconi mi chiese innanzitutto cosa ne pensassi di un mio passaggio a Il Giornale in qualità di direttore. Non nascosi di essere attratto da questa ipotesi, sostituire Montanelli mi attizzava. Ma aggiunsi anche che io stavo alla grande lì dove mi trovavo. L’Indipendente andava molto bene e le mie entrate erano soddisfacenti. Sottolineai, infine, che fintanto che Montanelli fosse stato alla guida de Il Giornale io non avrei mai osato scavalcarlo e che solo nel caso in cui Indro avesse deciso di abbandonare il timone per motivi suoi, io sarei stato interessato ad un mio passaggio al quotidiano di via Negri. Berlusconi la prese bene. Non era un tipo da scomporsi. Dopo il nostro primo incontro il futuro leader di Forza Italia mi chiamava spesso per farmi i complimenti per i miei titoli o i miei pezzi, mi diceva che il mio giornale gli piaceva molto. In occasione del ferragosto di quello stesso anno, il ’93, fui invitato da Silvio a pranzo, sempre ad Arcore.
«Mi trattengo a Milano per lavoro e sono da solo, porti anche sua moglie ed i suoi figli», mi pregò l’imprenditore. Mi presentai lì non accompagnato. A tavola questa volta Berlusconi si fece più insistente. «Venga da me, le affido la direzione di Canale5», mi disse. Io non avevo mai fatto televisione, avevo alle spalle solamente qualche piccola esperienza in codesto ambito, sono un giornalista della carta. Berlusconi mi fornì il nome ed il numero di un suo amministratore, un certo ingegnere Spingardi, augurandosi che potessimo raggiungere un accordo fissando un compenso. Insomma, l’uomo mi voleva a tutti i costi. Incontrai Spingardi, più per farlo contento che per negoziare, infatti la trattativa non andò in porto. Influì sull’esito infausto anche la reciproca antipatia tra me e questo amministratore.
Berlusconi, Vittorio Feltri in lacrime al Tg1: "La nostra ultima telefonata"
Vittorio Feltri, è in lacrime durante il collegamento telefonico con il Tg1, dove ricorda Silvio Berlusconi e sep...IL PARTITO A CHI LO DO?
Nei mesi successivi la stampa ci diede dentro con la diatriba infocata tra Montanelli e Berlusconi. Il primo non accettava che il secondo avesse fondato un movimento. Indro era incazzato nero, poiché aveva capito che il suo giornale sarebbe diventato un organo di partito. Si mormorava che Montanelli avesse intenzione di mollare la presa. Agli inizi di dicembre di quello stesso anno, il ’93, Berlusconi mi telefonò per chiedermi un consiglio. «Non so a chi affidare il partito, che ne pensa di Mariotto Segni?», mi chiese. «Mi sembra flaccido», osservai. «E Mino Martinazzoli come lo vede?», proseguì. «Anche peggio. Mino, lumino cimiteriale, è una specie di agente mortuario», risposi. Berlusconi rideva e mi ascoltava. Ad un certo punto incalzò: «Insomma, Feltri, lei chi metterebbe a capo di Forza Italia?». «Metterei Silvio Berlusconi. Perché, quando ero direttore de L’Europeo feci fare un sondaggio al fine di sapere quale fosse il cittadino più ammirato d’Italia e al primo posto risultò lei. Se decide di entrare in politica, il partito deve dirigerlo lei, altrimenti lasci perdere», conclusi. Sospetto di avere fornito a Forza Italia non solo il leader, ma persino il nome. Negli anni ’80 io, Walter Zenga e Nicola Forcignanò conducevamo un programma televisivo che si chiamava “Forza Italia”, trasmesso sull’emittente di Tanzi.
VIA NEGRI
Berlusconi premeva e mi chiedeva in modo sempre più incalzante di andare a Il Giornale. Ci fu un altro incontro, ancora una volta ad Arcore. «Ok, vengo al Giornale», dichiarai dopo estenuanti tentativi di convincimento. Le condizioni erano cambiate rispetto ai mesi precedenti. Montanelli stava andando via. Era deciso. «Quando Indro toglierà le tende, ammesso che ciò accada effettivamente, io accetterò di prenderne il posto. Di sicuro non verrò lì a dargli una gomitata», specificai. E, in effetti, Montanelli, sicuramente messo a dura prova da un Berlusconi che voleva scaricarlo, abbandonò il quotidiano da lui stesso fondato. Dimessosi, il posto per pochi giorni restò vacante. Nel mentre prese avvio la trattativa riguardante la mia assunzione. AL’Indipendente guadagnavo mezzo miliardo l’anno, ecco perché mi misi a ridere allorché i dirigenti de Il Giornale, nel corso di un colloquio, mi offrirono 600 milioni. Li mandai a quel paese senza esitazioni. Già non ero molto eccitato al pensiero di lasciare un quotidiano che vendeva molte copie, inoltre mi veniva proposto di farlo per 100 milioni in più. «Se vi serve un cretino, ce ne sono in giro tanti. Se avete bisogno di un direttore, io sono ancora per poco disponibile», dissi rivolgendomi a tutti i presenti, incluso Paolo Berlusconi. Poi lasciai la stanza. Davanti all’ascensore fui recuperato e riportato dentro. A quel punto mi offrirono 800 milioni e, per convincermi ad accettare, mi proposero un compenso anche per le copie vendute. Insomma, più avrei recuperato lettori più avrei incrementato i miei guadagni. Una bella sfida, che colsi al volo. Già dopo pochi giorni vendevo 30mila copie in più.
LA SFIDA CON LA VOCE
I pranzi con Montanelli si interruppero. Non sentivo di averlo usurpato. Non appena presi la direzione de Il Giornale uscì il mio primo articolo, quello di saluto ai lettori. Il giorno successivo, tra le 10,30 e le 11, ricevetti la telefonata di Indro. Parlava in modo pacato e sicuro, come sempre. Nella sua intonazione nessun accenno di rancore odi rabbia: «Vittorio, ti faccio gli auguri ora che sei diventato il mio successore, ho letto il tuo articolo di fondo e devo dire che mi è molto piaciuto. Mi secca solo di non averlo firmato io». Restai sbalordito ancora una volta dalla sua gentilezza. Montanelli era un vero signore. Nelle sue parole percepivo affetto. Forse voleva togliermi dall’imbarazzo. Quanta delicatezza!
Il Giornale andava abbastanza bene quando esordì il nuovo quotidiano fondato da Montanelli La Voce, che vendette da subito la bellezza di 500mila copie. Tuttavia, io ero tranquillo. Avevo studiato bene quel giornale e lo vedevo brutto. Non avevo nessun timore. Sapevo che La Voce sarebbe stata una meteora. Scintillante all’inizio e dalla vita breve. Infatti, durò solamente un anno. Da 115mila copie a gennaio del ’94, Il Giornale superò le 200mila a fine luglio. Indro mi portò via una cinquantina di giornalisti, tra cui Beppe Severgnini, sebbene di lui mi dicesse «Beppe è soltanto cipria», Marco Travaglio, Mario Cervi, e tanti altri.
Dopo un anno dalla sua uscita, La Voce vendeva 30mila copie o 40. Il giorno in cui chiuse io mi trovavo a Santa Margherita Ligure. Appresa la notizia, feci fare 10 righe sulla prima pagina, una colonna, per rispetto, al fine di informare i lettori che il giornale di Indro aveva terminato le pubblicazioni. Neanche una parola di commento. Non avrebbe avuto senso infierire. Rientrato a Milano, il giorno seguente, mi chiamò Montanelli per chiedermi di vederci. Ci incontrammo in un ristorante di corso Venezia, Santini. Mi appariva quasi stanco, ma sereno. «Ho dovuto chiudere il giornale. Aiutami, vorrei che tu riprendessi con te queste persone», e mi fece il nome di alcuni giornalisti. «Se posso, Indro, lo faccio più che volentieri», risposi. E, in effetti, ne feci assumere qualcuno. Mi segnalò Cervi, che reintegrai subito. Iniziò così una nuova fase di frequentazione tra me e Montanelli, che tornò aIl Corriere come editorialista.
Non seppi mai cosa Indro pensasse di me dalle sue labbra. Lo appresi leggendo Panorama, dove io peraltro in quel periodo curavo una rubrica di opinione e rispondevo ai lettori.
Intervistato dal settimanale, al fondatore del giornale che io dirigevo fu chiesto se fosse vero ciò che si diceva, ossia che io fossi un suo allievo. «Questo non lo posso dire, ma da come scrive sento che è un mio parente», fu la sua risposta. E poi: «De Il Giornale cosa ne pensa?». «È come avere un figlio drogato», dichiarò gelido ed ironico Indro.
Montanelli mi accusò di cavalcare il peggio della borghesia italiana, cosa che aveva fatto pure lui. Ciò che gli era sfuggito era semplicemente il fatto che era la borghesia ad essere cambiata. Io l’avevo seguita.
LA ROTTURA
Lasciato Il Giornale, fui invitato a cena a casa sua. «Avevi ragione tu, Indro, quando andasti via da via Negri. Sono stato lì quattro anni e mi sono davvero rotto i coglioni», gli confessai. Montanelli scoppiò a ridere. «Perché hai mollato?», mi domandò. «Ero stufo e, siccome avevo una cospicua liquidazione da riscuotere, ho sloggiato più che volentieri», spiegai. Ridevamo come matti. Lo divertiva il fatto che avessi strappato una bella vagonata di soldi, lui non era bravo a trattare con il denaro. Io, invece, quando c’è da riscuotere divento ancora più tignoso ed incazzato. Dopo qualche mese decisi di fondare Libero e la notizia venne diffusa. Mi trovavo a pranzo con Renato Farina al ristorante Il Porto quando nel tavolo in fondo alla sala vidi Montanelli, il quale si alzò e mi raggiunse. «Noto che non fai più parte del mio club, quello dei magri, hai messo su qualche chilo, caro Vittorio», poi aggiunse: «Tu, a differenza mia, sai fare bene i conti, ce la farai con il tuo Libero».
E poi la rottura. In diretta tv. Durante una trasmissione condotta da Santoro, Raggio Verde, in onda su Rai2, ci fu un’accesa discussione tra me e Indro. Era presente anche Travaglio.
Era il marzo del 2001. Non ci chiarimmo mai più. Indro morì. Mi dispiace non averci parlato, ma, in fondo, non c’era nulla da chiarire. Avevo ragione io.
Indro era andato via incazzato da Il Giornale perché Berlusconi si era gettato a capofitto nell’agone politico, io comprendevo le sue paure e ragioni, tuttavia il modo che utilizzava per criticarlo era ingiusto. Sosteneva che il leader di FI fosse un fascista, un despota, un pericolo per la democrazia, un manganellatore. «Caro Indro, per vent’anni hai sempre affermato che Berlusconi fosse il migliore editore che tu avessi mai potuto immaginare di avere, perché non ha rotto mai le palle. Ad un certo punto, da un giorno all’altro, hai capovolto la tua opinione, dipingendo l’uomo come una sorta di mostro», gli dicevo.
Il punto è che Indro era convinto che Berlusconi fosse il proprietario del suo giornale e lui il padrone assoluto. Ma il proprietario, se non gli vai più a genio, ti caccia. È una realtà schifosa, ma questa è. Siamo tutti liberi, certo. I giornalisti italiani sono i più liberi di attaccare l’asino dove vuole il padrone. Indro però non aveva torto, non sopportava che arrivasse qualcuno, quantunque fosse colui che mette il grano, a dettare legge imponendogli una certa linea, che magari avrebbe seguito di sua spontanea volontà se non fosse stata l’unica strada permessa. Devo ammettere che io andai via da Il Giornale poiché mi ero rotto le scatole delle pressioni ricevute non da Berlusconi ma dagli ominicchi del suo partito, che davano per scontato che il quotidiano che io dirigevo fosse al loro servizio.
Di Montanelli restano gli insegnamenti. Mi sembra ancora di sentirlo e non c’è mattina in cui io, giunto in redazione, non ripensi a queste parole: «Caro Vittorio, quando fai un giornale, devi sempre tenere presente che alla gente non interessano molto gli spiccioli della politica, per cui devi fare due articoli di fondo alternati, di cui uno contro un personaggio politico importante, ed il titolo deve essere “testa di cazzo”. Se invece fai un pezzo sull’Italia, il titolo deve essere “Paese di merda”. Questa è la tecnica migliore». E come un’eco si aggiunge Gaetano Afeltra: «Vittorio, ricordati sempre la regola delle quattro “s”, sesso, sangue, soldi e salute. E, infine, uno schizzo di merda qua e uno là». Certe persone restano per sempre, persino quando non ci sono più. Berlusconi è tra queste.