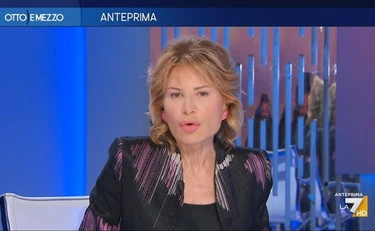Chi era Paolo Borsellino? Risposta facile: un magistrato antimafia, un simbolo della lotta contro il crimine organizzato, un eroe della nostra Repubblica. Giusto. Ma chi era Paolo Borsellino prima di diventare tutto questo? Bè, era un ragazzo di Palermo, uno studente e, cosa che spesso si tende a non ricordare, un attivista di destra. Sì, perché il giudice morto nel 1992 nella strage di via D’Amelio aveva le sue idee politiche, e non le nascondeva.
Questo, naturalmente, non significa che sia un “eroe di destra”. È un eroe di tutti. Ma è legittimo, anzi è ovvio, che a destra siano orgogliosi del suo passato “militante”. È una storia che spesso si tende a non ricordare, come detto, perché a sinistra non vogliono ammettere che un loro eroe possa essere stato di destra, addirittura “missino”. Eppure è così. E tra i pochi che questa vicenda la conoscono bene, anche se non ne ha parlato spesso, c’è Guido Lo Porto, storico esponente del Msi e poi di Alleanza nazionale, a lungo parlamentare e anche sottosegretario alla Difesa nel primo governo Berlusconi. Basta dire che quando militava nel Fuan, l’organizzazione degli universitari vicini alla Fiamma, da responsabile dell’ateneo di Palermo ha avuto come vice proprio Borsellino.
Adesso, Lo Porto, queste cose le ha raccontate in un libro, La Gara. La generazione di destra dal dopoguerra ad oggi (Fondazione Thule Cultura Edizioni Ex Libris, pagine 246, euro 18), uscito recentemente. L’amicizia con il futuro magistrato inizia al liceo Meli di Palermo, «ambedue studenti, io del secondo, lui del primo liceo». «Non si può dire», scrive l’autore, «che a quei tempi esistesse una vera e propria anagrafe associativa, gli studenti di destra appartenevano all’associazione studenti medi Giovanni Gentile, che transitò alla Giovane Italia allorché venne concepita e fondata da quel grande organizzatore che fu Massimo Anderson».
«Paolo e io», prosegue Lo Porto, «ci trovammo dentro anche grazie al comune impegno nel giornale d’istituto che, insieme ad altri, fondammo. Si chiamava Agorà ed era un foglio concorrente di altri giornali che proliferavano dentro le scuole, sia a destra che a sinistra». E poi: «Paolo scriveva su Agorà, puntualmente e rigorosamente coerente con la linea politica del giornale da me diretto».
Il percorso con Borsellino continua anche negli anni successivi. «Dopo la maturità classica», racconta, «ci ritrovammo all’università, a Giurisprudenza. Approdammo al Fuan, naturalmente, dove l’orizzonte politico era più vasto e più netto. Peraltro, l’ateneo di Palermo includeva gli studenti di Agrigento, Trapani Caltanissetta, con problematiche politiche, sociali ed economiche assimilabili, quelle della società italiana nel suo complesso: fare attività dentro l’università equivaleva all’impegno a livello nazionale». E qui Borsellino si accorse che avrebbe potuto avere anche un futuro in politica: «Scoprimmo che attraverso gli organismi rappresentativi universitari avevamo una grande occasione di confronto che non ci lasciammo sfuggire. La cogliemmo al volo, con tutta la forza della nostra passione. Borsellino ebbe un ruolo fondamentale. Senza mai rinunciare al carattere scherzoso-goliardico che lo contraddistingueva, trovò una giusta palestra per i suoi pensieri sempre protesi verso il bene comune; il seguito di cui godeva presso la base studentesca era evidenziato dal massiccio consenso che coronava ogni volta la sua candidatura alle elezioni universitarie. Sempre eletto al Congresso universitario (l’Assemblea rappresentativa di Ateneo), divenne praticamente il personaggio di spicco del Fuan Fanalino di Palermo. Fu il mio vicepresidente e, da allora fino al tragico epilogo, la nostra navigazione fu sempre allineata».
Già, Borsellino scelse poi la magistratura, facendo della lotta alla mafia la sua ragione di vita. Ma non scordò mai gli amici di quegli anni “militanti”. Ne parlò, in un suo libro del 1993 (“La guerra dei giusti”), anche il collega giudice Giuseppe Ayala. Alcuni «veri amici» di Borsellino, raccontò Ayala, «erano gli stessi che frequentava negli anni dell’università. Penso a Giuseppe Tricoli, il professore di storia con il quale passò l’ultimo giorno della sua vita. O ad Alfio Lo Presti, un bravo ginecologo. A Guido Lo Porto, il deputato del Msi.
Queste amicizie forti di Paolo mi hanno fatto riflettere su un punto, sull’assurda criminalizzazione dei missini, fra i quali ci sono tantissime persone perbene». Tornando al libro di Lo Porto, il suo racconto di questa amicizia si conclude proprio con la morte di Borsellino: «Quando venne trucidato, un funesto giovedì di luglio, mi trovavo nella mia casa di villeggiatura in compagnia di una squadra di carabinieri che in quel tempo mi toccò di avere come scorta a causa di una minaccia mafiosa. Fu uno di questi carabinieri che mi comunicò il triste evento e con lui mi precipitai in via D’Amelio, speranzoso che Paolo fosse sopravvissuto. Lo spettacolo che mi si presentò è noto. Per un amico come me fu però cosa diversa da quanti osservarono la scena senza l’afflato ideale che pervase in quel momento la mia anima: tutto si concludeva tragicamente come accade ai commilitoni che sul campo di battaglia vedono cadere lo sfortunato compagno d’armi; la somma dei sentimenti, dei pensieri, delle speranze, l’accumulo dei sogni e delle delusioni, tutto giace lì nel selciato di una città imbarbarita che non vuole eroi, ma vittime sacrificali».
«Partecipai ai funerali», conclude Lo Porto, «ma resistetti alla tentazione di unirmi nelle prime file alle lacrime di coccodrillo che copiose uscivano dagli occhi dei cerimonieri di turno; solo un abbraccio accorato alla vedova e uno sguardo commosso ai figli». Ultima nota: il 19 maggio 1992, all’undicesima votazione per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, il Msi lanciò proprio Borsellino. Il giudice prese 47 preferenze, solo quelle della Fiamma. Sarebbe morto esattamente due mesi dopo...