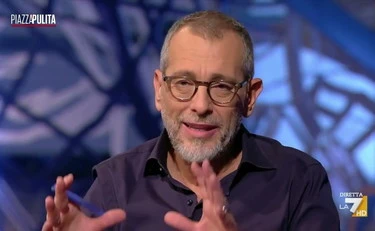Il riscaldamento globale ha sdoganato le conversazioni sul tempo che fa. Una volta relegate a stereotipate battute in ascensore con i vicini le discussioni sul clima hanno conquistato un posto centrale nella nostra società: se ne parla fra amici, a tavola in famiglia. Si litiga sugli anticicloni quasi più che sulla politica. La televisione fa la sua parte. L’ignoranza del cavernicolo, che si rimetteva interamente all’esperienza dell’altro, ci appare più saggia di questo nostro dibattito scientifico (televisivo) tutto verboso e vano. Questa propensione è confermata dalle chiacchiere pseudostoriche e pseudoscientifiche, come la tesi del «1816, l’anno senza estate». Tema diffuso da programmi televisivi inglesi e ripreso dalla Rai, in “Dietro le quinte della storia” con Piero Angela e Alessandro Barbero. Angela mostra un quadro. Si tratta di un tramonto con le navi di William Turner. «Tramonti strani», afferma Barbero.
Il professore aggiunge: «Un anno duro! L’ultima grande carestia in Europa. La causa scatenante fu l’eruzione vulcanica del Tambora in Indonesia nel 1815». Angela parla del sistema fragile del pianeta e Barbero spiega che la temperatura media, dopo il 1815, scese di un grado. Poi aggiunge con la solita enfasi: «L’Italia è stata molto colpita!» Arriva poi il tocco di classe: per il grande freddo, «Mary Shelley ne approfitta per scrivere il suo capolavoro, Frankenstein»! Non solo: nel 1816, «in Liguria si muore di fame». I contadini, quindi, emigrano in America. Sulla Costa Atlantica si gela e i contadini si dirigono all’Ovest. Angela conclude spiegando che inizia l’epopea del Far West... Si parla del pittore Turner.
Invece, il documentario originale inglese indugiava sulle nuvole dipinte da Constable. Per Angela e Barbero le nebbie dipinte da Turner contengono l’evento del cambiamento climatico del 1816. Purtroppo per loro è stato dimostrato che nei quadri del pittore londinese, come nei quadri successivi, cronologicamente, del parigino Claude Monet, si possono trovare le tracce dello smog, proprio attraverso quelle foschie che appaiono sempre nei loro quadri. Sono quindi i segni dell’inquinamento atmosferico nei primi anni dell’Ottocento, nel caso di Turner, e non quelli del presunto grande freddo del 1816. Barbero parla di grande carestia nel 1816. Sbaglia. Nella History of a six weeks’ tour through a part of France, Switzerland, Germany, and Holland di Percy Bysshe Shelley, stampato a Londra nel 1817, si parla dell’estate 1816. Shelley nota in Francia che «i campi erano rigogliosi d’abbondante raccolto» e da inglese osserva che l’assenza di recinzioni fu «la prima caratteristica che colpì il nostro sguardo».
La Liguria? La povertà fu causata non tanto dal clima, ma dal pessimo governo del Regno di Sardegna, che da pochi anni governava su Genova e la Liguria. Non erano bei tempi per i liguri, mentre in Piemonte, ad esempio, il conte Carlo Vidua, nel 1816, annotava le ottime annate di vigneti e risaie (testimone lo scambio epistolare con il suo segretario Evasio Ronfani). Stendhal, nel 1816, spende i suoi trentatré anni nel godere i piaceri artistici della Penisola. Alla Scala si rappresenta il “dramma giocoso” di Soliva, l’opera La testa di bronzo, che resta in cartellone per quarantasette volte: il freddo, quindi, non ferma i melomani. Nelle sue lettere del 30 settembre e del 20 ottobre 1816, Stendhal scrive del bel clima e dei piaceri milanesi e soprattutto di Byron, per lui il più grande poeta vivente (che era sopravvissuto a quel “freddo” 1816). Basta con questi tentativi maldestri di dimostrare che una volta faceva freddo per convincerci che oggi fa troppo caldo. Il riscaldamento globale c’è e lo vediamo dai colpi di sole che si prende Barbero.