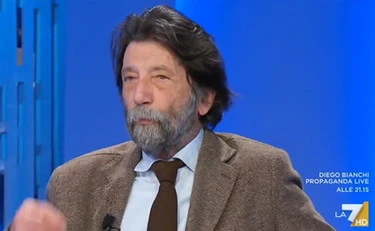F ra le innumerevoli opinioni taglienti di Federico Zeri c’era la profonda convinzione che non fosse il Rinascimento «il momento più alto della cultura italiana». Bisognava piuttosto guardare a ciò che era venuto prima, «all’epoca di Federico II, dal 1230 circa, fino alla peste nera del 1348. È il momento in cui l’Italia ha il suo più grande poeta, Dante Alighieri, e quello che per me è il momento figurativo più alto, cioè Giotto e la sua scuola», sentenziava il grande critico d’arte. Punti fermi, con poche concessioni al dibattito, profili di giganti ai quali Zeri aggiungeva quello dello scultore a suo avviso «unico, forse il più grande che abbia avuto l’Italia, Giovanni Pisano».
In questa chiave di anticipazione, vale la pena spendere dunque un altro nome grosso, Nicola Pisano, padre appunto di quel Giovanni citato da Zeri che adesso anche Alessandra Gianni, docente di Storia dell’Arte Medievale e di Iconografia e Iconologia presso l’Università di Siena, tratteggia come fondamentale figura di passaggio e innovazione nel suo I misteri del pulpito senese di Nicola Pisano (Sillabe, pp. 66, euro 18). Si tratta di un approfondito e agile saggio che analizza come mai prima d’ora il complesso programma iconografico del Pulpito del Duomo di Siena. Oltre 300 figure (sculture a tutto tondo e ad alto rilievo), sette pannelli scolpiti (la Visitazione e la Natività, l’Adorazione dei Magi, la Presentazione al Tempio e la Fuga in Egitto, la Strage degli Innocenti, la Crocifissione, il Giudizio Universale). Realizzato fra il 1266 e il 1269 in marmo di Carrara e imponente (supera i tre metri di altezza), a pianta ottagonale, il pulpito è un unicum di arte scultorea che fonde elementi ancora romanici ed esplora la tensione gotica, con un’attenzione particolare alla resa naturalistica delle figure e degli elementi architettonici.
Una drammaticità delle composizioni che, assieme alla maestosità della Cattedrale, folgorò Richard Wagner (soggiornò a Siena nel 1880): era quella, decise, la location perfetta per la scena conclusiva del Parsifal. Non solo. Gianni sottolinea come Nicola Pisano abbia introdotto «novità fattuali di primaria importanza dal punto di vista iconografico, storico e teologico», sull’onda del rinnovamento già proposto nel pulpito realizzato pochi anni prima per il battistero di Pisa, come lo Svenimento di Maria nella scena della Crocifissione, il viaggio dei Magi con corteo affollato di personaggi e animali esotici, il bacio al piede del Bambino da parte del re più anziano. Tutti temi che avranno largo seguito nei secoli successivi e che ruotano attorno al complesso concetto teologico della nascita della Chiesa e del suo continuo rigenerarsi attraverso il gruppo scultoreo del cosiddetto Cristo Mistico. Nel pulpito senese abbiamo di fatto la prima rappresentazione artistica del Purgatorio in un’opera così importante come il Pulpito di una grande Cattedrale. La fonte letteraria è l’Apocalisse di san Paolo, testo apocrifo di ampia diffusione nel medioevo all’origine della teologia del Purgatorio, la cui messa in scena precede di alcuni decenni la Divina Commedia (il Purgatorio dantesco è databile al 1316 circa) ed è una significativa novità nella storia dell’arte, anticipando tutte quelle che saranno le raffigurazioni pittoriche del Trecento. Una scelta artistica che mostra come i fermenti di riflessione teologica sul destino delle anime dopo la morte in quel secolo si stessero intensificando per giungere a dichiarazioni esplicite da parte dei pontefici (1254 Innocenzo IV e 1274 Concilio di Lione).
Altra nuova interpretazione proposta da Gianni riguarda il concetto della “caduta di molti”, resa attraverso l’inedita rappresentazione del vecchio re Erode. Raffigurato solitamente come il mandante potente e crudele della Strage degli innocenti, qui egli è invece un anziano che crolla, sostenuto a fatica dai personaggi vicini. Il tema era stato raffigurato da Nicola già nel suo precedente pulpito del battistero di Pisa nel quale aveva citato un vaso attico che si trova nel camposanto pisano che rappresenta “l’ubriachezza di Bacco”. La presenza di quel vecchio cadente, giustificata dagli storici dell’arte con numerose interpretazioni, era secondo la Gianni, sia a Pisa che a Siena, la volontà di incarnare le parole del vecchio Simeone che tiene in braccio il Bambino: “Egli è qui per la caduta di molti”. Di importanza non secondaria anche il personaggio che compare in uno dei girali del Cristo mistico con barba e saio, sempre identificato come un francescano (Francesco o Bonaventura da Bagnoregio): si tratta di in realtà non di un frate, ma di un monaco cistercense riconoscibile dallo scapolare. «Tale presenza in effetti è più plausibile dal momento che il committente del pulpito fu il converso cistercense, della vicina abbazia di San Galgano, fra’ Melano, Operaio del duomo di Siena», spiega Gianni, «questo fatto pone in luce il ruolo del pensiero cistercense - in particolare di san Bernardo di Chiaravalle - nel programma iconografico del pulpito e sul suo accento fortemente drammatico solitamente interpretato in chiave francescana».