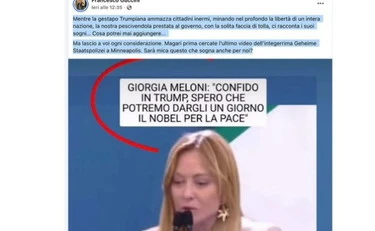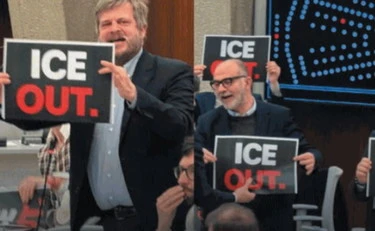C’è tutta la visione del mondo che ha animato per decenni, e in una misura minore anima ancora, la sinistra intellettuale diffusa nelle parole con cui Gianna Fracassi, segretaria generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL, ha liquidato l’approvazione l’altro giorno in Consiglio dei Ministri del decreto legge che riforma l’esame di maturità.
E ci sono le parole-totem, e francamente irriflesse, che si usano in queste circostanze, quasi una sorta di tiritera o “canzone d’organetto”, per dirla con Nietzsche (manca per pudore l’epiteto di riforma “fascista” ma alla fine in molti da quelle parti siamo sicuri che non la disprezzerebbero). Il provvedimento, che cerca di ripristinare un minimo di serietà negli studi, sarebbe «punitivo e regressivo», ci riporterebbe «indietro di decenni», riporterebbe a «pratiche superate e autoritarie».
Quanto poi al ritorno alla denominazione di “esame di maturità”, sostituita nel 1997 dal ministro Berlinguer in quella di “esame di Stato” (dal vago sapore di “Stato etico”), essa non rappresenterebbe «l’evoluzione didattica e pedagogica maturata negli ultimi anni».
PARTECIPAZIONE
E poi c’è il mito della “partecipazione” la quale imporrebbe di giustificare ogni tipo di comportamento in nome di una sorta di “morale superiore”. A proposito dei ragazzi che, nell’ultima sessione di esami hanno fatto scena muta all’orale, il ministro Valditara, stabilendo che da ora in poi ciò non sarà più possibile, avrebbe dato «una risposta autoritaria» perché «ogni protesta rappresenta una forma di partecipazione attiva e il ministro dovrebbe ricordare che lo scopo della scuola della Repubblica è proprio educare alla partecipazione».
Ovviamente, la Fracassi non salva dall’accusa di «evidente ritorno al passato» neanche l’esame orale, che verterà su quattro materie ben precise e non più su un colloquio «libero su un argomento scelto dalla commissione. In definitiva, saremmo in presenza di un provvedimento che opera significative trasformazioni del modello di scuola» (e alla dirigente sindacale non passa per la testa che ciò potrebbe essere anche un complimento).
Come si vede il leitmotiv della presa di posizione della Cgil è il presunto “passatismo” della riforma di Valditara. Vengono perciò abilmente occultati tutti gli aspetti presenti nella riforma connessi al rapporto fra formazione e mondo del lavoro, apertura ad un uso accorto dell’Intelligenza Artificiale, centralità della persona (e quindi in primo luogo dello studente) nella valutazione complessiva dell’orale. L’ideologia di un progresso unidirezionale e le cui tappe sarebbero già scritte, usato come una clave contro chi non starebbe «al passo con la storia», comporta due conseguenze: da una parte, porta ad aderire a “filosofie della storia” esse sì datate e superate dall’evoluzione culturale e politica; dall’altro, porta a disconoscere la coesistenza nella storia di una molteplicità di tempi storici, in un nesso indistricabile di vecchio e nuovo, che oltre ad essere acquisizione ormai pacifica degli studiosi, è fattore di salvaguardia della libertà umana di scegliere di volta in volta i provvedimenti che ritiene migliori ad affrontare le sfide del tempo senza porsi il problema se siano ereditati dal passato o nuovi di zecca.
SESSANTOTTO
L’impressione è che invece molta parte della sinistra intellettuale, politica e delle professioni sia essa sì superata, rimasta ferma alle idee che erano all’avanguardia cinquanta anni fa, sull’onda lunga del Sessantotto, e che alla prova dei fatti si sono dimostrate fallimentari. E che soprattutto non ci permetterebbero di competere in un mondo ove la formazione è sempre più centrale e ha bisogno non di persone che abbiano un titolo o un pezzo di carta in tasca ma che siano preparate e “mature”.
Più radicalmente, la clava del progresso non permette di ragionare sui contenuti, come ci si attenderebbe da un sindacato propositivo. In fin dei conti, ciò che viene rifiutato è pluralismo di idee che è proprio della dialettica democratica. Nessuno vieta ai progressisti di avere e far valere le loro idee, ma esse non possono pretendere di squalificare le altre giudicandole a priori “passatiste” e “fasciste”. Anche quando, come nel nostro caso, sono quelle di buon senso proprie della maggioranza degli italiani.