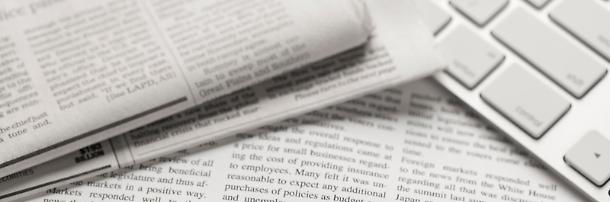Nel 2001 e nel 2003 si discusse della possibilità di espellere o sospendere un Paese membro dell’Unione Europea o semplicemente lasciare la porta aperta perché qualcuno se ne potesse andare. Anche in sede di Trattato di Lisbona, l’argomento riaffiorò, ma fu subito lasciato cadere. Si preferì optare per cavilli legali e burocratici con l’intento di rendere perenne e perpetua l’adesione alla Ue. In realtà non è proprio così. Anzi l’articolo 50 del trattato di Lisbona rappresenta la sola strada percorribile per chi voglia divorziare dalla moneta unica e dai vincoli comunitari. La procedura di addio impone alla nazione che vuole abbandonare l’Unione di comunicare la scelta al Consiglio. A questo punto si apre un negoziato che si dovrebbe chiudere con un accordo in grado di fissare le modalità del recesso, con una delibera adottata a maggioranza dal Consiglio e approvata dall’Europarlamento. Si fa cenno anche alle tempistiche: ovvero dall’avvio della separazione passeranno due anni. A quel punto potrà consumarsi il divorzio. Nel frattempo, ovvero dall’entrata in vigore dell’accordo di recesso, i Trattati smettono di essere applicabili per lo Stato in questione. Stando alle interpretazioni non sembrerebbe possibile lasciare la moneta unica senza dire addio all’Unione. Ciò che è certo è che nessuna nazione può aderire all’Emu (European and Monetary Union) senza prima aver passato tutti gli esami per diventare membro Ue. Un interessante report di Credit Suisse del 2011 dal titolo «European Economics and Strategy» si chiedeva se sia possibile una uscita volontaria dall’euro da parte della Germania. Posto il fatto che si tratterebbe di una drastica inversione di rotta (l’euro è di fatto un progetto tedesco) all’inizio causerebbe ingenti perdite alle banche, fondi pensione e alle assicurazioni di Berlino. Gli asset allocati in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo rappresentano il 31 per cento del Pil tedesco. Con una passività immediata del 13 per cento. Senza contare la perdita di liquidità che Berlino subirebbe non trovandosi più in una posizione di emettitore benchmark. Se poi la rottura dell’euro avvenisse in modo traumatico, ovvero senza un coordinamento da parte della banca centrale, il costo complessivo dell’operazione si aggirerebbe sempre secondo Credit Suisse sui 430 miliardi di euro, comprese le perdite dirette della Bce e le svalutazione di tutti gli investimenti nei Paesi oggi considerati periferici. Più recente, rispetto al paper, è la proposta dell’economista portoghese autore del bestseller «Perché dovremmo abbandonare l’euro», Joao Ferreira do Amaral. Ipotizza la creazione consensuale di un nuovo Sme. Gli Stati che lo desiderano annunciano, senza abbandonare l’euro, di tornare in una sorta di nuovo sistema monetario europeo, accettando però una banda di fluttuazione superiore al 15%: a quel punto i bilanci delle banche dovranno tenere conto delle svalutazioni, ma scorporare il credito verso famiglie e imprese. Per evitare il cosiddetto credit crunch lo Stato potrà prestare moneta alle banche emettendola direttamente. Interverrà la Bce che, tramite uno strumento mensile di controllo delle fluttuazioni (crawling peg) e in caso concedendo direttamente denaro, impedirà che l’euro “nazionale” superi la percentuale di oscillazione concordata. A quel punto, dopo un anno o due, stabilizzata la valuta, il divorzio potrebbe avvenire senza troppi danni collaterali. La strada del nuovo Sme non avrebbe certo i costi di una rottura violenta, ma per percorrerla servirebbe una variante all’articolo 50. E visti i tempi della Commissione quanti anni dovremo attendere? Basti pensare che per scrivere il Trattato ne sono serviti nove. di Claudio Antonelli